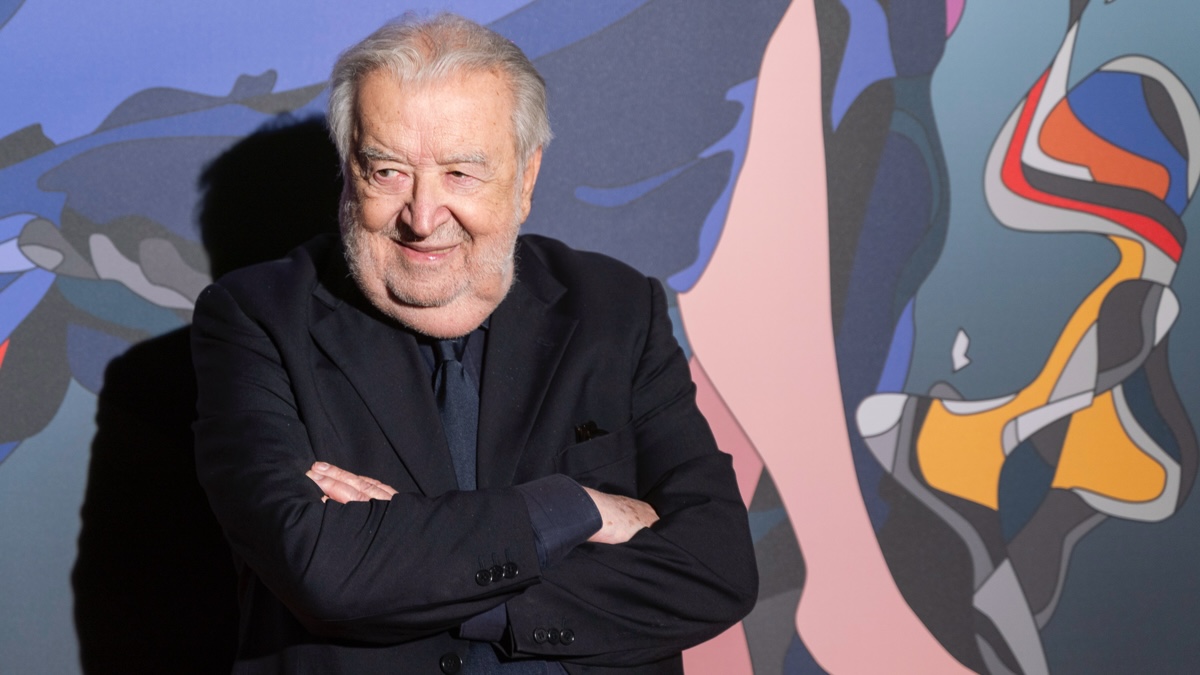Ci sono persone che riempiono la stanza quando vi entrano, con il loro carisma. Claudia Gerini, dai modi semplici e genuini, ci riesce, rimanendo alla mano, non le serve attirare l’attenzione o il “lei non sa chi sono io”. Ed è qualcosa che noti subito, sa farsi rispettare senza dover mostrare i muscoli, non si dà arie da intellettuale ma non disdegna di intavolare discussioni complesse. Un ufo in un mondo del cinema dove ci si divide troppo spesso tra divi inarrivabili (pochi), salottieri modello Grande Bellezza (alcuni), illuminati un po’ snob (la maggior parte) o la riserva indiana del cinema popolare che troppo spesso è costretta a interpretare una parte che non è la loro.
L’aiuta aver fatto la gavetta, aver lavorato con tanti autori diversi (Verdone e Pieraccioni, Gibson e Castellitto, Genovese e Rubini, Tornatore e Andò, Garrone e Soldini, Manetti Bros e Gabriele Muccino), ognuno con uno sguardo sul cinema e sul mondo profondamente diverso, così come l’aver affrontato la palestra della televisione quando ancora c’era chi ne capiva. Al Bardolino Film Festival, diretto da Franco Dassisti, dove lei è stata presidente della giuria dei corti e insignita del Premio Città di Bardolino, davanti a una tavola imbandita in cui si parla di tutto, chiede di questo nuovo giornale, della sua linea editoriale. È curiosa e attenta. E si scivola in un’intervista un po’ diversa dal solito.
Nel giro di un anno ha girato il suo primo film da regista e ha scritto una biografia, a un’età peraltro in cui solitamente non ci si guarda indietro. Anno di svolta?
In realtà Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice (ed. Piemme) è ispirato alla mia vita perché dentro, è vero, ci sono delle cose che ho vissuto, ma non era mia intenzione fare un resoconto dell’esistenza di Claudia Gerini, tirare una linea. Ti direi che è stata una coincidenza che in uno-due anni ho affrontato queste due sfide, ma ho abbastanza esperienza per sapere che niente succede per caso.
Eppure non era mia intenzione fare un film come regista, era probabilmente un desiderio che non conoscevo, era ben nascosto sotto l’inconscio, però l’ho fatto proprio perché ho pensato di fare un passo avanti, protetta dal fatto che Emma di Tapirulàn la conoscevo bene, potevo governarla avendola immaginata io e che essendoci un’unica location poteva essere tecnicamente più facile. Ho scoperto poi che l’unità di luogo, spazio e di fatto tempo è una sfida bella tosta. Lo stesso vale per il libro: me lo hanno chiesto e all’inizio, confesso, avevo rifiutato. Poi, però, hanno cominciato a venire delle idee e mi sono detta “buttiamole giù, poi vediamo”. Diciamo che era il momento giusto per entrambe queste novità, in fondo la vita l’ho sempre vista come quel gioco in cui devi unire i puntini per formare un disegno che esiste già.
Non sarà che voleva mettersi in una posizione un po’ più scomoda?
Quella è un’abitudine che ho: un attore, un autore, uno scrittore di solito rimane nella sua comfort zone, soprattutto se deve affrontare ciò che non conosce. Io invece ho deciso di fare un film insidioso, che mi mettesse alla prova, ma che fosse anche fuori da qualcosa che rispetto troppo per “toppare”, ovvero la commedia. Per me è sacra, è una religione, ho lavorato con cineasti talmente grandi, maestri di quel genere, e la amo così tanto, che farne una brutta non me lo sarei mai perdonato. Mi sarei buttata dal ponte più alto di Roma. E poi quello è un genere che ha bisogno di sceneggiature straordinarie, che funzionino perfettamente. Meglio un thriller psicologico, su una terapeuta che non si ferma mai – letteralmente – e che cura gli altri rinchiudendosi in una prigione di vetro, perché ha un dolore, un trauma dentro che la blocca lì. Però è vero, adoro mettermi nei guai. Qui trovare il ritmo e tenerlo, non potendo giocare su diverse location, non è stato affatto facile. Ecco perché quando gli spettatori mi fanno i complimenti o quando in sala li vedo quasi avere il fiatone come la protagonista che corre ininterrottamente sul suo tapis roulant, penso di avercela fatta.
Detto questo, da La sconosciuta a Non ti muovere, un’anima più nera, più drammatica l’ha mostrata.
Mi piacciono i personaggi sospesi, ambigui, anche spiacevoli a volte. Dove puoi usare quella che chiamo l’intelligenza recitativa, lavorare con le sfumature più pericolose e difficili. Da autrice, ma anche d’attrice, alla fine mi rendo conto che io voglio che anche lo spettatore stia scomodo, che si diverta e venga intrattenuto, ma non si senta al sicuro. Per questo nel film ho curato tutto nei dettagli, penso alle musiche che non ho voluto convenzionali: ho lavorato con un maestro, Geoff Wesley (uno che da Battisti a Baglioni a Zero, solo in Italia ha arrangiato per i migliori, e nel mondo ha portato le sue musiche sui palchi più importanti), che ha lavorato con i Bee Gees, ha prodotto un dischetto come Una donna per amico. Ma eravamo a distanza, io a Roma e lui a Londra, e mi mandava sequenze musicali lunghe, elaborate, e nonostante sia uno dei più grandi non mi facevo problemi a dirgli di no, a modificare anche il suo lavoro per il bene del film. Diciamo che lui non è abituato a essere contraddetto, non è stato facile.
Per lei la musica è il primo amore?
È un mondo che amo e in cui mi sento a mio agio. Ecco perché l’edizione, il montaggio sonoro mi è piaciuto tanto affrontarli. E in generale, lasciamelo dire, l’università di un cineasta è il montaggio, lì impari tanto, più che sul set.
Ci ha preso gusto? Il secondo film da regista è già pronto?
Ancora no. Ma so che mi piace questa cifra stilistica, il passo del thriller, l’alternarsi tra tensione e momenti di leggerezza, sentivo che era un linguaggio che capivo e parlavo bene. Però posso dirti una cosa, nel prossimo film mi piacerebbe forse togliermi dal cast. Perché recitare per se stessi è difficile, devi concentrarti su troppi tavoli, probabilmente come attore finisci per tutelarti meno di quanto possano fare altri registi, perché hai uno sguardo d’insieme. Poi è pure vero che – ma non diciamolo ai registi per cui ho lavorato – io mi dirigo sempre. Scherzi a parte, ci sono autori, ma sono pochi, che ti guidano con mano ferma e non ti lasciano molto spazio, altri che ti lasciano proporre delle cose, altri ancora che ti danno sin troppa libertà che ti chiedono “come la faresti?” e dopo la tua risposta dicono “ottimo, vai”. Io ho la fortuna che molti si sono fidati di me, delle mie scelte e credo di essere una che capisce il linguaggio espressivo altrui e quindi se ci metto qualcosa di mio, lo faccio nel solco della sceneggiatura, dell’idea di chi dirige. Poi l’attore, mentre interpreta, è autore. Ognuno di noi dà un tono, una direzione ai personaggi che un altro non saprebbe dare. Ognuno ha sfumature, colori diversi. Ti scelgono anche per questo, per quello che puoi aggiungere al loro lavoro.
Da interprete vorrebbe essere un po’ più diretta, quindi?
I grandi autori lo sanno fare, da Tornatore a Amelio, e a volte sì, è bello essere quasi una macchina: ti equalizzano, ti sintonizzano su certe frequenze, e se sono bravi ti portano dove non immagini. Se un autore si impone, e riesce a domarti, spesso ne esci arricchito. Negli ultimi tempi sono molto più fedele allo script, alle indicazioni del regista, penso al film di Liliana Cavani, L’ordine del tempo (che sarà a Venezia): mi sono affidata alle parole dello sceneggiatore, alle indicazioni di chi mi dirigeva, ho percorso ogni pausa, congiunzione, spunto, con grande diligenza. Non mi sono aggiustata, cucita il personaggio addosso. Sì, ha ragione, mi sa che mi piace stare un po’ scomoda.

Francesca Inaudi, Claudia Gerini e Valentina Cervi in una scena de L’ordine del tempo, di Liliana Cavani
L’impressione è che lei abbia una grande consapevolezza del suo talento, delle sue doti, di quello che vuole. E da sempre, se è vero che a 13 anni mandò un selfie, quando ancora si chiamavano autoscatti, per Miss Teenager.
Beh, ora ho 51 anni, sarà anche normale che io sappia più o meno quanto valgo, no? Credo che se uno ha un’attitudine, anche solo inconsciamente sa da subito cosa desidera, deve solo scoprirlo. Poi nello spedire a Cioè (una rivista per adolescenti cult in quegli anni) quella foto, di nascosto dai miei, c’era anche dell’incoscienza. Non avevo seno, avevo la pancetta, ma in qualche modo volevo dire “io sono qua, ho voglia di mettermi alla prova”. Poi, al di là delle qualità che mi riconoscono gli altri, so che a ogni progetto porto almeno l’amore per questo lavoro, la professionalità e un’esperienza che nasce dalla tanta strada che ho fatto.
Il segreto del suo successo?
Provo a rispondere, anche se è una domanda trappola, di quelle che non sai mai come vuoi e devi rispondere. Diciamo che ne ho tre. Non ho mai puntato sulla bellezza; affronto ogni film come se fosse il primo; non mi interessa quanto sia importante il ruolo, ma quanto posso farlo bene io. Anche se ho solo tre pose. Fai conto che nell’ultimo film dei Manetti Bros, U.S. Palmese, sono la poetessa di Palmi, un ruolo piccolo ma bellissimo e ci ho messo dentro tutto. Ah, ho un quarto segreto: non ho mai smesso di divertirmi, giocare.
Molti suoi colleghi si sono dimenticati che recitare in inglese si dice play, in francese jouer…
Se è così non li capisco. Io gioco tantissimo, poi le commedie le amo perché puoi spingere al massimo, mi piace farlo ancora dopo trent’anni, quindi mi sento tanto fortunata. Però è vero, tanti colleghi mi dicono spesso “ma non ti sei rotta?”. Sono quelli che magari si mettono a dirigere perché recitare ha cominciato ad annoiarli. Io invece ho ancora una voglia matta di stare anche davanti alla macchina da presa, truccarmi, mettermi parrucche, cambiare voce, tono, dialetto, gesti.
Provocazione. Ai nostri tempi Non è la Rai era il male. Eppure da lì sono uscite due delle attrici più amate e longeve: Sabrina Impacciatore e lei.
Gianni Boncompagni diceva sempre, guardandoci, che il paradiso se lo immaginava così. Alcuni ci consideravano lolite, ma Gianni e la “zia” Enrica Bonaccorti in realtà ci hanno permesso di imparare tanto, erano attenti ai nostri talenti e compatibilmente con quel contenitore cercavano di valorizzarli. Eravamo ragazze carine, sorridenti, ma ballavamo, cantavamo, facevamo piccoli sketch e se lo rivedi oggi, era una trasmissione pulita, molto meno maliziosa di quanto la accusassero. Avevamo ben più dignità di letterine o veline, diciamolo. Anche perché la malizia, semmai, era di chi guardava Non è la Rai in un certo modo. E poi, non dimenticarlo, era molto inclusivo, c’erano ragazze di tutte le provenienze. Quell’esperienza comunque è stata una palestra, mi ha insegnato a tenere la diretta, che quando si accende la luce rossa devi essere, senza possibilità d’appello, divertente, frizzante, convincente. Mi ha lasciato anche tante amiche, da Alessia Barela a Sabrina stessa.
Non è che le è venuta voglia di tornare in tv?
Sì, devo dire che ultimamente è una cosa che farei molto volentieri. Mi sta venendo voglia di fare un varietà.
Dobbiamo aspettarci la nuova Raffaella Carrà?
No, direi più una Franca Valeri, o fare un omaggio a Sandra Mondaini, mi piacerebbe fare un varietà al femminile, proprio classico, cioè fare quattro puntate di sketch, duetti, far ridere, com’era il varietà una volta. La tv è un bel posto, se hai voglia di farla bene. Vorrei fare delle incursioni e poi andare via, uno speciale tv e poi tornare al cinema, riproporre un po’ di omaggi delle donne del passato, non qualcosa di stabile, che duri mesi.
Prima vedere Franca Valeri o Mina alla guida di una grande trasmissione era qualcosa di normale. Ora al massimo c’è Milly Carlucci. Si stava meglio quando si stava peggio?
Attenzione, i maschi dominano la tv da sempre, ma è vero che quella attuale dà alle donne ancora meno spazio rispetto a quegli anni. E poi c’era una visione diversa allora, con tutti i difetti di quell’epoca, la tv sapeva però essere anche molto moderna, il modo in cui proponeva la figura femminile lo era. Forse era persino più avanti della società. Guarda Sanremo: la figura della donna è “episodica”, si mette il vestitino, fa il suo discorsetto, chiunque sia, e poi saluta e tutti si sentono a posto con la coscienza. Mina, Raffaella Carrà, Delia Scala, l’eleganza e il talento di una Loretta Goggi dove sono ora? E se ci fossero, arriverebbero dove sono arrivate loro? Erano trasmissioni, performance elegantissime.
Cosa la aspetta nell’immediato futuro?
Un’opera di Carmine Elia per Netflix (ecco lui è uno che dirige davvero): è una serie (Sara, con Teresa Saponangelo), e due esordi sul grande schermo. In particolare quello di un mio amico sceneggiatore, non posso dire chi, ma che mi sta piacendo molto. Poi, ovviamente, sto provando a metter su la mia opera seconda da regista, credo sarà una smart comedy, una commedia romantica. Ma per ora è solo un’idea.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma