
Gabriele Salvatores ha 73 anni e ha vissuto venti vite. Tante quante i suoi film, almeno. Senza contare i documentari e gli spettacoli a teatro, gli amori tormentati, gli incontri straordinari – Billy Wilder, Roman Polanski, Lucio Dalla, Harvey Weinstein, David Cronenberg, Federico Fellini – e le avventure con gli amici di sempre: Diego Abatantuono, Silvio Orlando, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino. La vita, la (paura della) morte, la malattia, la politica, il peyote, un canguro, l’Oscar: in Lasciateci perdere (titolo originario di Mediterraneo, Oscar al miglior film straniero nel 1992), la sua biografia scritta per Rizzoli con la giornalista Paola Jacobbi, c’è tutto.
Ventuno capitoli più una parentesi astrologica in cui il regista ripercorre con ironia – e straordinaria onestà – vita e carriera. L’infanzia, la decisione di far cinema a partire da una diagnosi che più nera non si può (leucemia: si scoprirà poi che era policitemia), i film più amati (Io non ho paura e Nirvana), quelli più sottovalutati (Educazione siberiana), i più tormentati (Denti, “un film depresso”, Amnesia, “figlio del Prozac”), quelli mai realizzati (Il cromosoma Calcutta, dal romanzo di fantascienza di Amitav Ghosh, e Anna, che Niccolò Ammaniti volle girarsi da solo).
E ancora l’amore con Rita, ex moglie di Abatantuono, i tre anni di crisi curata dall’astrologo di Marisa Laurito, gli scazzi: quello doloroso con il produttore Maurizio Totti, quello inspiegabile con Sergio Rubini (“Mi ha ghostato”), quello mai avvenuto con Abatantuono, appunto, che non se la prese per il “ratto” della moglie, sul set di Marrakech Express. Al montaggio del suo prossimo film, Napoli New York (“Uno dei miei ultimi film – scrive – quanti altri set avrò la forza di dirigere?), Salvatores risponde al telefono a THR Roma.
Un mese di lavoro, 210 pagine, venti capitoli. Cosa ha scoperto di se stesso?
Che sto camminando come un funambolo tra la necessità di continuare a fare film e la voglia di godermi piccole cose della vita cui non ho mai dato abbastanza importanza. E che forse ho perso proprio per inseguire il cinema. Vivo una fase strana: da una parte la vita che mi chiama, dall’altra il lavoro.
Cui non rinuncia: a che punto è il nuovo film?
Ho quasi finito il montaggio di Napoli New York, che è tratto da un soggetto, anzi un racconto di 80 pagine, di Tullio Pinelli e Federico Fellini. Ci sono un bel po’ di effetti speciali, per cui ci vuole tempo. Ma sono contento, ancora una volta è un film diverso dagli altri. I protagonisti sono due ragazzini napoletani bravissimi, di 12 e 9 anni, e c’è Pierfrancesco Favino che è straordinario. La storia è quella di due scugnizzi che senza una lira si imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York. È un modo per parlare di cose di oggi, ma in maniera non ideologica.
I suoi film sono stati distribuiti negli Stati Uniti da Harvey Weinstein. Che tipo era?
Harvey capiva di cinema e ha dato una spinta importante per il rinnovamento della cinematografia americana. Quando gli Studios erano in crisi, lui ha posto attenzione sui film stranieri. Era molto intelligente e capace. Peccato che avesse dentro un demone, decisamente non condivisibile. Credo ne abbia fatte di tutti i colori.
Mai avuto problemi?
Quando Stefania Rocca venne a New York con noi (per Nirvana, ndr), aveva la macchina di Harvey fissa sotto all’albergo. Mi chiamava e mi diceva: “Che devo fare?”. Le rispondevo: “Chiuditi in camera. E non aprire”.
Nel libro, però, critica la cancel culture e difende Polanski.
Io del metoo condivido la partenza e i motivi, ma sono meno d’accordo su cosa stia diventando il movimento. Tutti gli artisti per me hanno dentro un demone, piccolo o grande. Se ci pensiamo, anche la perla dell’ostrica, in realtà, è un tumore. Le chiese cattoliche sono piene di quadri di Caravaggio, che era un assassino bisessuale e non esattamente uno stinco di santo. Bisogna separare il giudizio della persona da quello dell’artista.
Woody Allen l’ha mai incontrato?
Alla scorsa Mostra di Venezia, per caso. Scendeva dalla barca, me lo sono ritrovato davanti. Mi sono letteralmente inginocchiato e gli ho baciato la mano. Lui mi ha guardato interdetto, poi mi ha fatto una carezza.
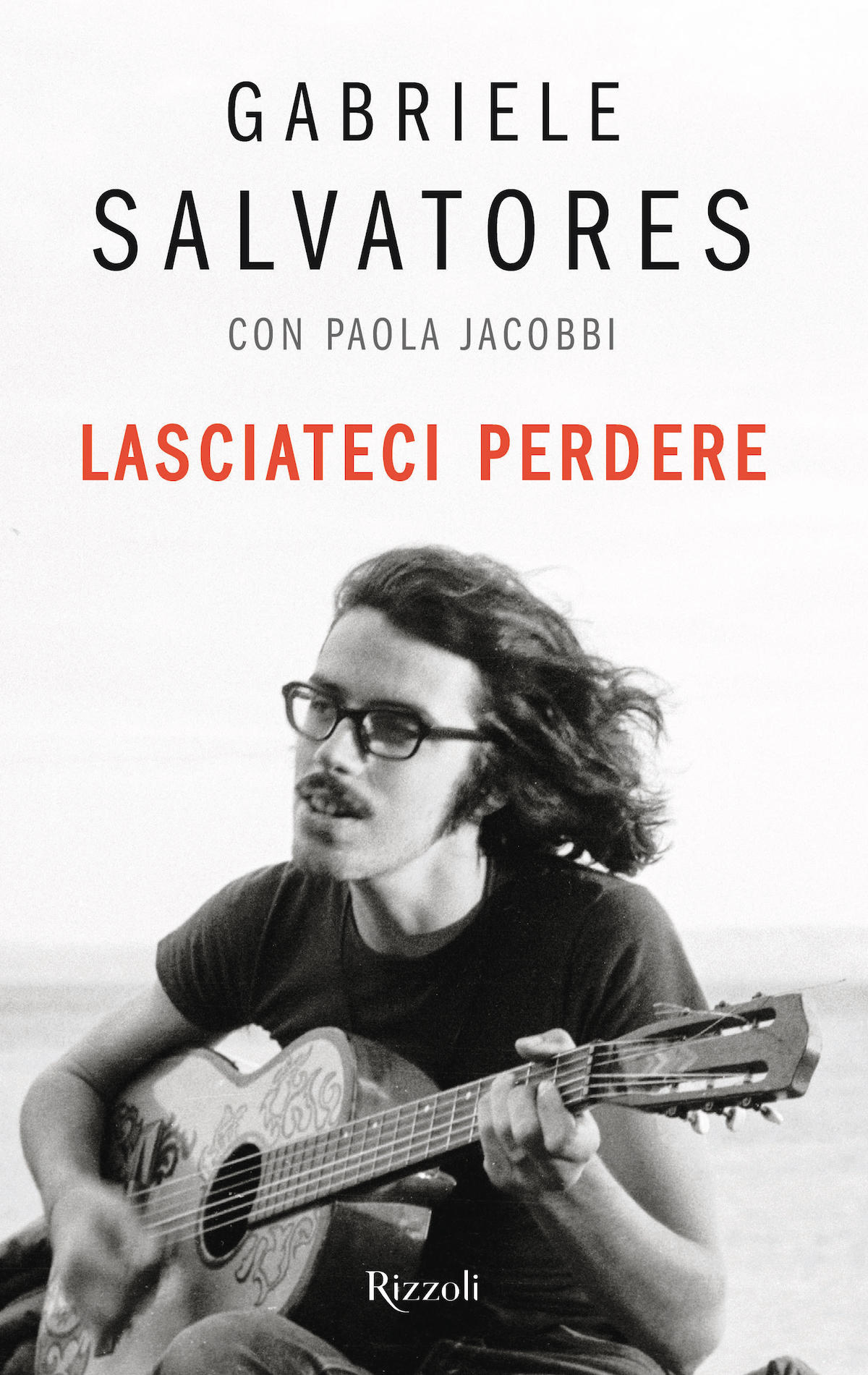
Lasciateci perdere, la biografia di Gabriele Salvatores scritta da Paola Jacobbi
Scorriamo la sua agenda: Christopher Lambert. Dice che colleziona porcellini. Di peluche.
Sì, e da Highlander non me lo sarei mai aspettato. È fissato col film Babe maialino coraggioso, colleziona maialini e pupazzetti rosa. Lambert è una persona molto carina. Uno che ha il coraggio e la forza di dire: “Io non sono un grande attore, ma vivo grazie all’affetto del pubblico”. Quando me l’ha detto, avrei voluto abbracciarlo.
Quentin Tarantino, in giuria con lei a Venezia nel 2010.
L’ho visto anche altre volte, ma non abbiamo mai parlato di cinema. Non è facile discutere di cose serie con lui: gli piace troppo cazzeggiare.
Billy Wilder.
Un maestro. L’ho incontrato agli Oscar, parlammo di commedia: mai dimenticare l’aspetto della tragedia, diceva. Da napoletano (Salvatores è nato a Napoli, ndr), capisco benissimo cosa intenda.
Agli Oscar il discorso gliel’ha preparato la sceneggiatrice di Frank Sinatra. Ma lei gliel’ha cambiato. Che c’era scritto?
Era tutto ringraziamenti: a mamma, a papà, cose così. Io ho detto: sì, ho capito la mamma, ma c’è una guerra in corso (la prima guerra in Iraq, ndr). Gliel’ho stravolto e ho chiuso con “Stop the war, life is better”.
E l’hanno portata via dal palco.
Il mio momento Piccola Piuma (l’attrice apache che rappresentò Marlon Brando agli Oscar nel 1973, ndr).
Ha diretto Luca Barbareschi a teatro. E poi?
L’ho conosciuto da ragazzo, una persona simpatica e intelligente. Ma la pensiamo diversamente su tante cose. A differenza di Elio De Capitani, che tifò contro il mio Oscar ma poi fu felice quando lo vinsi, lui fece il contrario. Prese a odiarmi. Disse che parcheggiavo la Porsche a due passi dai centri sociali.
Ha una Porsche?
Ma figuriamoci.
A trent’anni le diagnosticarono la policitemia. Cos’è?
Il mio midollo produce più piastrine, quelle che aggregano il sangue e impediscono le emorragie. Si controlla prendendo degli antiaggreganti. Fa ridere, perché la malattia mi è venuta fuori proprio nel momento in cui il gruppo che aveva fondato il teatro dell’Elfo si stava disgregando. Quella diagnosi, che all’inizio fu di leucemia, mi diede la spinta per lasciare la famiglia del teatro e cominciare a fare un pezzo di strada da solo, al cinema. Girai il mio primo film subito dopo.
Durante la lavorazione di Puerto Escondido provò il peyote. Altre esperienze con le droghe?
Sono cresciuto in anni difficili e ho visto gente morirmi di fianco. Mi è capitato di soccorrere un attore dell’Elfo, che durante le repliche del Satyricon non entrava in scena. Lo trovai in bagno, con la siringa nel braccio e il sangue ovunque. La perdita del controllo mi ha sempre fatto una grandissima paura. Non mi sono nemmeno mai ubriacato.
Neanche con lo champagne che Cecchi Gori le mandò per l’Oscar?
Niente, mai. Però dall’altra parte ho una grande curiosità: sono cresciuto con la letteratura anni ’60 e ’70, gli scrittori beat, le porte della percezione. Sento che c’è qualcosa aldilà di quel che vediamo e ho pensato che le droghe potessero aiutare a sentirlo. Non ho mai usato sostanze chimiche. Ma posso dire con tranquillità che le canne me le sono fatte. E può anche capitare che, se sono molto agitato, un tiro me lo faccia ancora.
Non è competitivo, non sgomita, non invidia. Come sopravvive?
Non ho mai avuto un metodo, ho sempre seguito quello che mi veniva. Ho fatto quel volevo. Roma la adoro, per esempio, ma non riesco a starci. Faccio fatica a viverla, cosi come non riesco a frequentare le feste, le cene. Ma non è una scelta ideologica. Io non me la sento. Preferisco seguire l’istinto.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma









