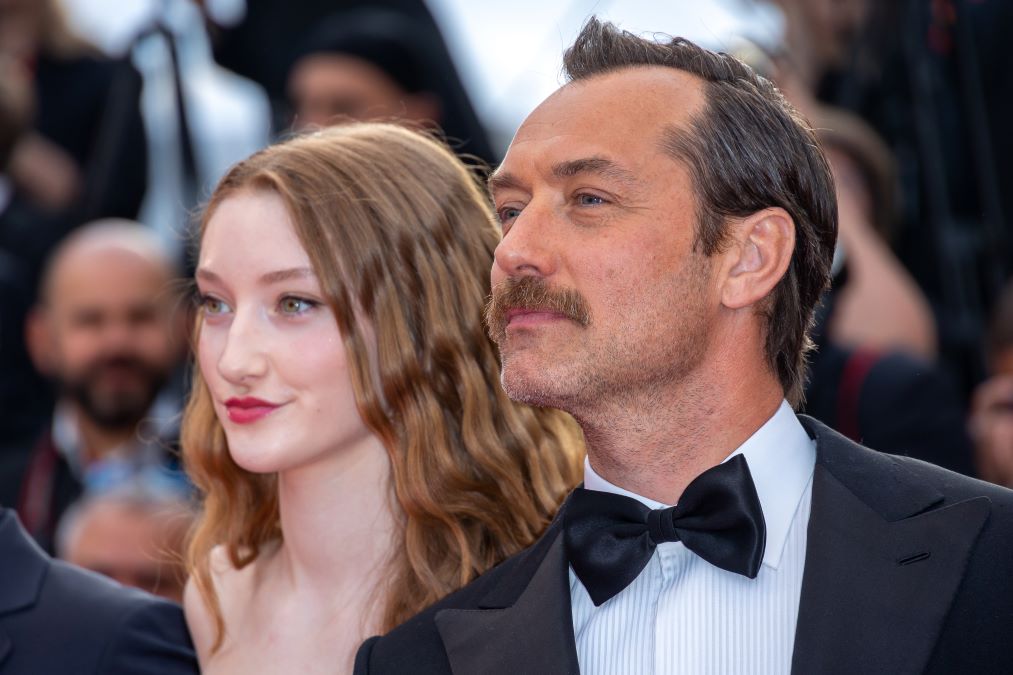Andare per gradi. È l’unico modo per poter affrontare Dune – Parte due. Dividerlo, spezzettarlo, fare in modo che ogni punto, spunto, appunto trovi il proprio posto. Nessuna Bene Gesserit può aiutarci. Bisogna sedersi, fermarsi, farlo da soli. Prendere ogni granello di sabbia di Arrakis e analizzarlo senza lasciare nulla al caso. Anche il dettaglio più insignificante può influenzare l’universo, come un topolino del deserto.
Per cominciare, partiamo dalle intenzioni di Denis Villeneuve, regista e co-sceneggiatore insieme a Jon Spaihts dell’adattamento dal primo libro del Ciclo di Dune (nella Parte uno affiancati anche da Eric Roth). “Tutto è nuovo”. E lo è davvero. Lo aveva dichiarato tempo addietro Villeneuve, che non voleva un sequel che somigliasse troppo al primo film, ben più contemplativo della (semi) resa dei conti della casata degli Atreides, nebuloso sul pianeta di Caladan e assolato all’arrivo su Arrakis.
Una prima parte che aveva saputo spazzare via l’ansia da fallimento provocata dai fantasmi del tentativo mastodontico di Alejandro Jodorowsky e il deludente giocattolone del 1984 di David Lynch. E che prosegue con una muscolosità, una prontezza e un’azione che pompa inedita forza nei disegni ancestrali di Paul e del suo cammino. Speculare al precedente racconto eppure evoluto, come i suoi personaggi. La lotta, la rivelazione, le tavole della legge che hanno predizioni da elargire e profezie da veder portate a termine. È il tempo dell’arrivo del Messia. È il tempo di Muad’dib.
Dune – Parte due: religione o destino?
Sebbene è della svolta action di cui più di ogni altra cosa si vuole sapere e parlare, è impossibile analizzando Dune 2 non soffermarsi sul portato religioso di un romanzo che ha trasformato l’esperienza personale dello scrittore Frank Herbert in storia fantascientifica, adottando una vera e propria tramutazione non dall’acqua al vino, ma dalla visione mistica del suo libro-mondo ai film. Dune – Parte due porta all’apice il percorso messianico di Paul Atreides, mostra la morte (metaforica, ma per un momento anche fisica) del protagonista, affinché venga compiuta la sua sorte: diventare il Kwisatz Haderach.

Zendaya è Chani in Dune – Parte due
Per essere profeta, per ricoprire il ruolo del leader, Paul deve abbandonare tutto, ma non vuole farlo. Non vuole rinunciare all’amore per Chani, non desidera dare adito alle credenze che, se dovessero raggiungere il culmine, provocherebbero stragi di innocenti e guerre sante in suo nome. Di morti sulla coscienza non ne vuole. Di far parte di un nuovo popolo, della gente della donna che ama, sì. Ma non è così facile.
Approcciate le tribù dei Fremen, Paul dovrà guidarli rappresentando un’incarnazione tra la figura di Gesù e quella di Mosè: da una parte incorporando le abilità sovrannaturali che lo rendono “altro” rispetto al resto della gente, dall’altra abbracciandone il ruolo di liberatore come colui che salvò il popolo di Israele dall’Egitto. È nell’etimologia dei Fremen il loro essere liberi, nome avuto dalla crasi dell’inglese “free” e “men”, (“uomini liberi”). Già indipendenti nel loro habitat desertico, autonomi e autosufficienti, i Fremen sono però pronti a farsi guidare dall’imminente Salvatore.
Con un’attenzione ossequiosa nei confronti della spiritualità insita in Dune, non certo sottile da cogliere, ma in un equilibrio da maneggiare come si avesse tra le mani qualcosa di fragile, la Parte due di Villeneuve fa di ruoli e religione il tessuto del racconto. Una trama fitta, orlata su un arazzo in movimento dove si ha l’impressione che tutto è già stato scritto, ma ogni cosa può ancora cambiare. Qualcuno, qualcosa ha tracciato le strade di tutti. E tutti possono dunque decidere se solcarle o ribaltarle.
Il controllo delle Bene Gesserit (e l’ossessione di Frank Herbert)
Un tentativo, sfuggire al destino per non essere visto come un profeta, a cui Paul Atreides dovrà finire per cedere, spinto soprattuto dalle macchinazioni della madre, Lady Jessica. È di nuovo la religione che lo impone. Le Bene Gesserit, ripresa dell’educazione gesuita imposta allo scrittore Frank Herbert nella sua infanzia, riflette sulle strategie con cui la fede agisce per portare ad attuazione i propri scopi.
È il bisogno spasmodico di controllare tutto a far stendere piani su piani alle varie Reverende madri, seguendo un solo obiettivo fin dall’inizio: mantenere la propria posizione di stabilità e dominio. Con mano ferma e una lettura che risulta chiara allo spettatore, Dune – Parte due approfondisce il turbamento del romanziere statunitense sulla finta libertà con cui vengono ingannate, monitorate e manipolate le persone.

Rebecca Ferguson e Lady Jessica in Dune – Parte due
La paura del controllo, teorizzata e vissuta sulla pelle di Herbert (imparentato con il senatore dell’anticomunismo Joseph McCarthy e che dà un nome al villain della storia all’orecchio “sovietico”, Vladimir Harkonnen), ha le fondamenta nel complesso di una religione che detta regole e fondamentalismi e in una politica territoriale su cui hanno veto solamente i potenti. Solo chi si allea e fa patti di sangue può trovarsi al tavolo dei più forti. Chi promette stirpi che non si interromperanno e antepone potere e eredità al tornaconto personale.
Tutto è sotto il giogo di un’angoscia dovuta non solamente all’afa secca del deserto, ma all’impossibilità degli uomini e delle donne di agire al di fuori delle strutture sociali, economiche e territoriali che si sono innalzate secoli e secoli or sono. Anche in questo caso, morire è l’unica maniera, per un po’, di liberarsene. Avvelenarsi con l’Acqua della Vita mostra insieme la via, ma anche che in verità non c’è nessuno spazio di manovra. Stessa cosa per il lavoro cinematografico di Dune. Denis Villeneuve ne ha dovuto rispettare il peso e lo spirito, tentando di fare di schemi di gioco e conquiste di potere la base per un racconto epico.
La messinscena e le interpretazioni di Dune – Parte due
Sulle assi strutturali della storia di Dune – Parte due, il regista innalza la propria visione cinematografica. Che è diversa da un’altra sua opera fantascientifica, Arrival, e insieme si discosta anche dalla precedente pellicola della saga fantasy. Nell’introspezione ricercata dalla Parte uno, il ritmo lento e gravoso del film dava solennità alla Casa degli Atreides e al suo compito di sorvegliare il mercato della spezia per ordine dell’Imperatore.
Perso tutto e andato a fuoco ogni cosa, rifugiatisi nel deserto e diventati tutt’uno con l’ambiente che li circonda, Paul e Lady Jessica assumono in loro la fiamma dei soli che imbevono di luce il deserto di Arrakis insieme alla loro incandescenza.
Dune – Parte due è più robusto del film che lo ha preceduto, così come il corpo di Paul Atreides è più forte di come lo avevamo trovato nella pellicola del 2021. Il vigore delle responsabilità, della rabbia e della vendetta si sprigiona nella messinscena di una pellicola che mantiene la medesima solidità sia nelle scene di lotta che nei semplici scambi dei dialoghi.
La potenza viscerale che ne deriva è la sua croce e la sua delizia. È cedevole, vulnerabile, manchevole in alcuni punti proprio perché di una passionalità tale che a volte perde la bussola della ragione – soprattutto negli eccessi e nelle caricature dei suoi protagonisti – che rinforza però con una grinta e una carica con cui dà anche alla regia e alle sequenze un vero senso di “mitologia”.

Austin Butler in una scena di Dune – Parte due
La perfezione di certe scene, il tocco estatico e fermo, incredibilmente elegante di Denis Villeneuve, è la firma di un regista di cui si accettano anche le sbavature più ingenue, le trovate più emotive. Eccelle nei totali mozzafiato, nella gestione di veicoli massicci, armi futuristiche, anche in scontri corpo a corpo in cui le lame sferzano lasciando senza fiato.
A volte, invece, il deserto gli ruba un po’ il cuore e il sentimentalismo di Dune si trasforma in riprese sconclusionate e pura ricerca d’atmosfera. Anche alcuni primi piani agli attori peccano di un’esagerazione dovuta all’esigenza di caratterizzare al massimo ogni personaggio, ma di cui sarebbe bastato abbassare di un tono la loro espressività per scoperchiarne il talento.
La (non) fine di Dune
Arrivati all’ultimo dei tasselli con cui si è cercato di racchiudere l’universo-Dune, è bene soffermarsi su un finale che rispetta più o meno la fedeltà col primo capitolo della saga letteraria di Frank Herbert, ma che lascia ulteriormente aperto un conflitto continuo tra cinema e serializzazione.
Pur chiuso il conflitto tra Paul e gli Harkonnen, per il protagonista alla fine di Dune – Parte due si spiana un’intera narrazione che dovrà ancora essere raccontata e di cui non è stata data notizia di una possibile realizzazione.
I vertici staranno aspettando di scoprire (a proposito di disegni mistici) il destino del sequel, il cui (non) finale è soltanto un altro dei passaggi di un piano superiore a cui i credenti (in questo caso: il pubblico, i fan, gli spettatori) non potranno che affidarsi. Aspettando di vedere le sorti di un dittico che, a ogni modo, ha fatto la storia. E che, soprattutto, ha riabilitato il nome di Dune al cinema.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma