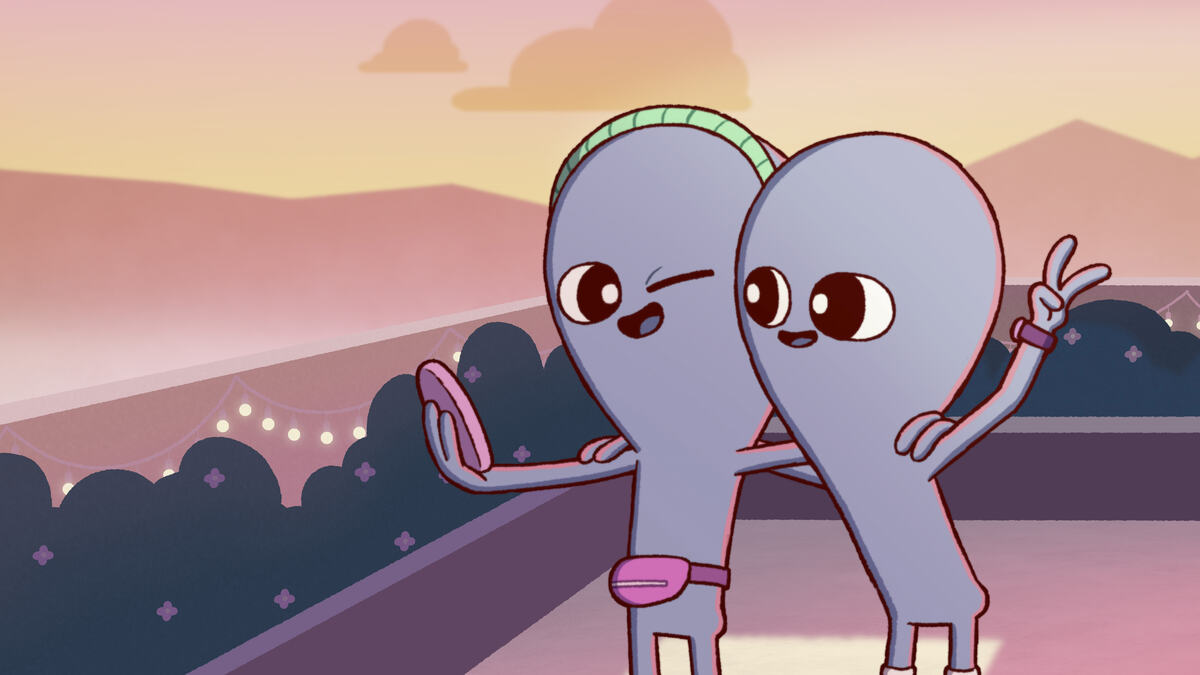Nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia Carlo Sironi debutta nella sezione Orizzonti con Sole. Storia di due ragazzi, di una gravidanza surrogata e di un amore pronto (forse) a sbocciare. Nel 2024, in occasione del festival di Berlino, il regista e sceneggiatore torna mettendo nuovamente a confronto due mondi, prendendo come spunto sempre l’adolescenza, calandola stavolta nelle dinamiche dell’amicizia, del controllo e della malattia.
È Quell’estate con Irène il film in anteprima nella categoria Generation con protagoniste Noée Abita e Camilla Brandenburg. Giovani che si incontrano su un’isola da cui decideranno di fuggire, pronte per la stagione più travolgente e entusiasmante della loro vita.
Come nasce Quell’estate con Irène dopo il debutto Sole?
In maniera abbastanza bislacca. Credo non mi succederà mai più. Stavo ascoltando To Wish Impossible Things dei The Cure, un brano liquido, che trasporta in dimensioni sognanti. Dura cinque minuti e per tutto il suo tempo mi sono immaginato le protagoniste. Mi è venuta in mente l’isola in cui ambientare la storia, la loro fuga, il dover affrontare una malattia che le mette a confronto con la morte. La storia era lì, nella durata di una canzone. Mi ha evocato alla mente due compagne di liceo, non avevo mai visto delle persone tanto libere e convinte nell’esprimere ad alta voce il proprio affetto. Così ho buttato tutto su pagina, l’ho messo in un cassetto e l’ho ritirato fuori quando ho finito con Sole.
Per la sceneggiatura si è fatto affiancare da Silvana Tamma. Bisogno di un occhio femminile?
Sarebbe facile rispondere di sì, ma in realtà prediligo la condizione femminile, non so nemmeno io perché. Non me lo chiedo nemmeno, non voglio. È come chiedersi: perché Vincente Minelli raccontava così bene le donne? Quando cerchi di psicanalizzare troppo finisci per privare le cose di senso. Sono domande senza un’autentica risposta e, se si trova, si finisce per banalizzare il discorso. Tutto ciò che so è che voglio continuare a esplorare l’universo femminile, come quello dei ragazzi.
Quindi non si è chiesto neanche perché continua a raccontare il mondo degli adolescenti?
Me lo sono chiesto. Credo sia per guardarsi indietro. Forse tornare all’adolescenza è una fuga dalla realtà, che non significa rifugiarsi nella fantasia. Mi sono però reso conto che non mi interessano le storie della gente della mia età. Sarà che anch’io non mi sento tutt’ora grande, sia da un punto di vista umano, che cinematografico. Sarà perché ho cominciato questo lavoro più tardi del previsto, fino ai ventisette anni lavoravo nel comparto fotografia, non avevo la smania di fare il regista a vent’anni. Ciò che so è che il mio voler parlare di adolescenza ha come fulcro la giovinezza nella sua essenza. Sono sicuro che se raccontassi una storia di adulti lo farei nello stesso modo. Anche per questo sono felice di essere nella sezione Generation della Berlinale.
Nessuna epifania, quindi, sul lavoro del regista?
Mio padre era regista, non mi piaceva l’idea di fare lo stesso (Alberto Sironi, Il commissario Montalbano, ndr.). Quando ho deciso di provare è stata una fortuna, ma avere un modello in casa può essere tanto affascinante quanto un respingente all’idea di assomigliarci. In più non credevo, e non credo tuttora, di avere la presunzione adatta.
Il secondo film è più ambizioso del primo?
No. Non lo so. Forse? Sole parlava comunque di maternità surrogata, pur essendo una storia d’amore. Quell’estate con Irène è sicuramente più bizzarro. È un oggetto strano, leggero, nel senso migliore del termine. È anche il motivo per cui l’ho ambientato negli anni novanta: poter tradire l’idea che ricordiamo delle estati del passato. Volevo avesse l’alone di un sogno ad occhi aperti, non una parentesi storica realistica. È liberatorio fare, pensare, ideare dei period pieces. Puoi tradire, falsare la memoria. Pensiamo agli anni settanta del cinema di Paul Thomas Anderson, in ognuno dei film la stessa epoca non si somiglia mai.
C’è qualcosa che accomuna Sole e Quell’estate con Irène, gioventù a parte?
Uso linguaggi molto diversi. È l’espediente a essere lo stesso. Due persone che non avrebbero alcun motivo per riconoscersi l’uno nell’altra e che, pur nelle rispettive differenze, soprattutto per quelle, trovano il modo di scoprirsi. Sono figure che si riconoscono in un mondo di monadi separate. Mi piacciono i registi che spaziano pur mantenendo un tocco identificabile, e vorrei che il mio fosse distinguibile, pur mescolato alle atmosfere estive e estemporanee di Un ragazzo, tre ragazze di Éric Rohmer e l’ispirazione da We Are Who We Are di Luca Guadagnino, di una vitalità esaltante.

Un’immagine di Quell’estate con Iréne, di Carlo Sironi, passato alla Berlinale 2024
Come ha trovato Noée Abita e Camilla Brandenburg?
Ho visto per la prima volta Noée sul grande schermo. Mi trovavo a Parigi, stavo scrivendo Sole e andai a vedere Ava di Léa Mysius. Da quel momento ho capito che avrei voluto lavorare con lei. Quando con Silvana ci siamo messi a delineare i caratteri delle protagoniste di Quell’estate con Irène è stato chiaro che dovevamo trovare un’attrice simile a Noée. E, dopo un mese di ricerche, ci siamo chiesti: perché non mandarle il copione? Alla fine non solo ha accettato, ma ha anche imparato l’italiano in poco tempo. Per Camilla, invece, è stato il volto. Ha un viso antico, abbinabile a qualsiasi tempo.
C’è anche molto cinema?
Ci sono i primi film di Jane Campion. C’è Goodbye First Love di Mia Hansen-Løve, tra le autrici più interessanti e troppo poco considerate della nostra generazione. C’è il desiderio di riprendere a piene mani dalle nostre estati, quelle a cui ci aggrappiamo, e che Silvana ed io abbiamo ritrovato in Graduate First di Maurice Pialat, il cui titolo originale è ancora più bello: Passe ton bac d’abord. E poi tanto, tanto cinema francese anni sessanta, quel tipo di racconti che sembrano non avere un vero tempo e spazio, ma in cui tutto avviene lì, immediato, nel tempo di un racconto.
Lei se la ricorda un’estate che le è rimasta addosso?
L’estate del viaggio in Croazia con gli amici e delle prime video 8. Non a caso anche le protagoniste di Quell’estate con Irène troveranno degli oggetti che releghiamo alla memoria, a una traccia di ciò che rimane. Durante la nostra vacanza tutti hanno usato la videocamera e tutti sono stati ripresi. Non si era ancora abituati a essere continuamente davanti all’obiettivo, si vedeva da come si cambiava il proprio atteggiamento. La camera era un magnificatore che modificava i comportamenti, mentre imprimeva un ricordo.
Ha anche il brano di quelle estati?
Truly Madly Deeply di Savage Garden. E il remix di Sciolgo le trecce ai cavalli.
Che tipo adolescente era?
Irrequieto. Famelico di nuove esperienze. Un osservatore, che cercava di capire la vita attraverso la letteratura. Ricordo ancora quanto rimasi impressionato da un testo come Pan del norvegese Knut Hamsun. Per questo mi rivedo molto nel personaggio di Clara. Durante la scrittura Silvana recitava spesso un brano di Walter Whitman: fuggiamo veloci come fa la Natura. Era così che ci sentivamo, è così che si sentono le protagoniste e non è un caso che Favigniana, e tutto il territorio della Sicilia, hanno un ruolo tanto importante nel film.
Le protagoniste devono confrontarsi con la malattia in un’età precoce, in cui non si pensa di essere finiti. Si diventa adulti quando si entra in contatto con la morte?
Tutti a sedici anni viviamo il paradosso di sentirci immortali pur avendo capito che c’è una fine. È curiosa la posizione umana, dobbiamo tenere a mente che potremmo morire, ma per andare avanti dobbiamo cercare di ignorare questo pensiero. L’isola in cui si trovano le protagoniste, e da cui vogliono sfuggire al controllo, è la rivisitazione di istituti e campus che esistono realmente in cui va una fascia di ragazzi, dall’infanzia fino ai vent’anni, che ha vissuto una malattia oncologica e in cui vengono preservati finché non ritenuti forti abbastanza. Abbiamo parlato con diversi di loro e ciò che era chiaro era il loro bisogno forsennato di vita. Il cercare di scrollarsi di dosso un’ombra che, pur essendo quasi scomparsa, li tiene ancora sotto il suo giogo.
Alla fine i The Cure è riuscito a inserirli nella colonna sonora?
Sì, nei titoli di coda, ma in realtà il resto delle musiche sono un insieme di atmosfere da musica folk anni venti. C’è finito anche un brano contemporaneo al pianoforte di Michael Nyman mai utilizzato da Peter Greenaway per un mediometraggio, una canzone punk hardcore, Ravel e tre pezzo di etnomusicologia molto gioiosi. Volevo che il film fosse un jukebox. Ho sempre ammirato i registi che sapevano sperimentare abbinando la musica in maniera strana e antitetica alle immagini. Non a caso uno dei miei film preferiti di sempre è Paranoid Park di Gus Van Sant.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma