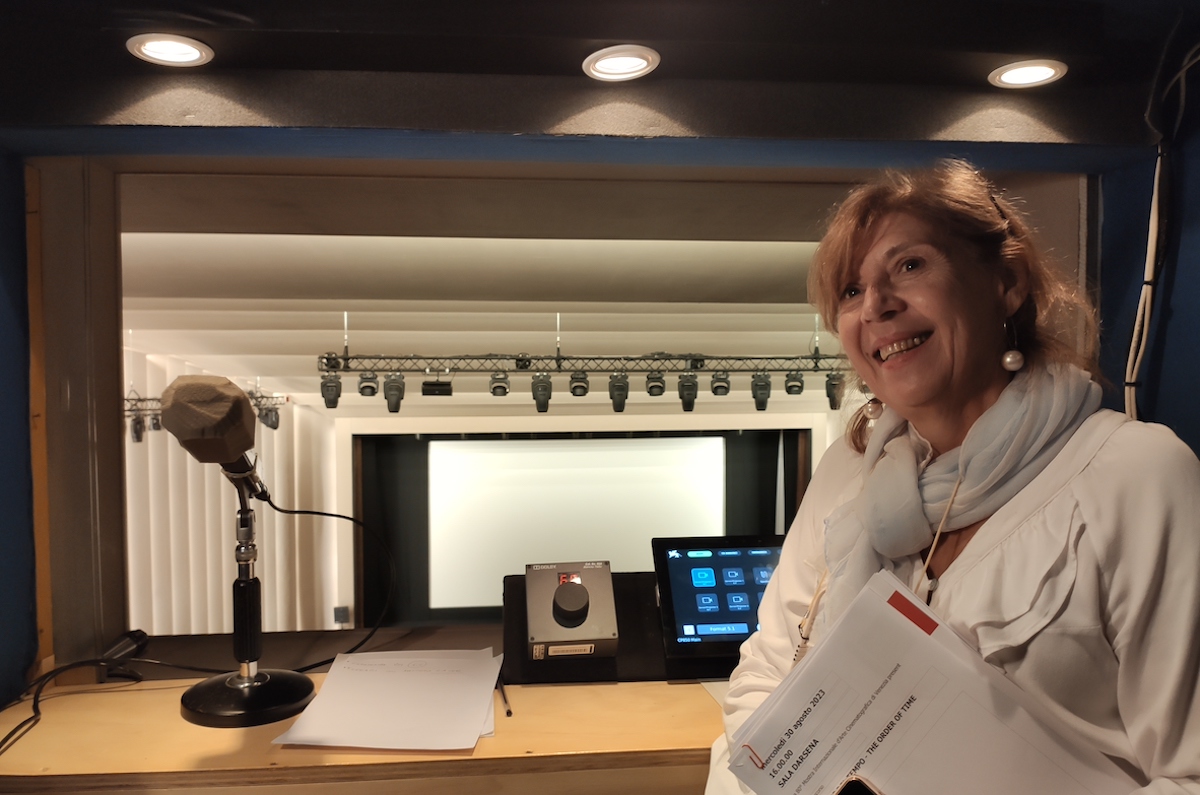“Non avevo idea che il programma delle Giornate degli Autori fosse così ricco. Sono rimasto stupito!”. Tommaso Santambrogio è l’unico italiano in concorso alle GdA 2023 con Gli oceani sono i veri continenti (dal 31 agosto al cinema). Film di apertura ed esordio al lungometraggio del regista che nel 2019, sempre alla Mostra del cinema, aveva presentato un corto dal titolo omonimo. Ora quella storia – ambientata a San Antonio De Los Baños, paesino dell’entroterra cubano – risuona ancora più forte grazie a tre diverse linee narrative che procedono su binari paralleli ma che parlano della stessa storia fatta di migrazione, memoria e separazione. “Raccontare certe storie con un determinato sguardo è fondamentale per comprendere la contemporaneità”.
Un corto del suo film era stato già presentato alla Settimana della critica di Venezia nel 2019. Perché ha sentito il bisogno di riprendere quel lavoro e ampliarlo in un lungometraggio?
In realtà è nata prima l’idea del lungometraggio. Ero ospite di una residenza artistica alla scuola di cinema di Cuba. Ero arrivato già con l’idea di voler girare qualcosa che mi desse l’opportunità di abbracciare un po’ tutte le generazioni della realtà cubana e cercare di fotografare la condizione della sua umanità. Volevo fare una sorta di mosaico rispetto alla tematica della separazione e della migrazione. Quando avevo scelto di farlo, nel 2019, avevo iniziato a girare da solo, in stile più documentaristico. La storia di Alex ed Edith, ma anche la storia di Milagros e dei dei due bambini. Chiaramente non approfondendo abbastanza, soprattutto le ultime due.
Ma nel corto compare solo una storia.
Nel momento in cui ho terminato di strutturare il progetto mi sono reso conto che l’unica storia che avevo sviscerato abbastanza da poter realizzare e restituire a pubblico era quella di Alex ed Edith, mentre avrei avuto bisogno di molto più tempo e molta più ricerca per affrontare le altre due storie. Soprattutto di approfondire e di passare del tempo a Cuba. La scelta è così ricaduta sul fare un cortometraggio solo su una delle tre storie. Ma l’idea di lavorare su tre linee parallele che si alternavano era presente fin dall’inizio. Tant’è che Gianluca Arcopinto, il produttore che mi ha seguito dalla prima fase, aveva presentato un cut esplorativo con le tre storie. Un lavoro che desse l’idea del tipo di indagine che stavo portando avanti.

Una scena di Gli oceani sono i veri continenti, film di apertura delle Giornate degli Autori
E poi?
Nel momento in cui è uscito il corto a Venezia, nel 2019, con Gianluca ci eravamo trovati per parlare del lungometraggio. Già a fine settembre avevo un trattamento presentato con tutti i personaggi, le foto, le immagini, la lavorazione sulle lettere dell’Angola che stavo ancora indagando. È stato un lavoro estremamente connesso e e non la classica operazione in cui il corto è l’avamposto del lungo. È stato tutto un processo molto organico
Utilizza un bianco e nero brillante che va in contrasto con l’immaginario che abbiamo di Cuba, fatto di colori sgargianti. Una scelta dalla valenza narrativa?
Sì, assolutamente. Volevo levare la patina superficiale dell’immaginario collettivo occidentale rispetto a Cuba. Un primo strato che fa rientrare in una comfort zone lo spettatore per andare all’essenza di quella che era l’umanità cubana. Un po’ il fine di tutto il lavoro, nel senso che l’obiettivo era riuscire a catturare e a dare la possibilità di esprimere quali erano le loro urgenze, le loro tragedie quotidiane alle persone. E il bianco e nero aiutava in questa direzione, perché andava a scavare quello che di primo impatto ci riconduceva a un certo tipo di idea di turismo, di immaginario. Poi secondo me Cuba è un’isola che per luoghi e strutture si presta molto al bianco e nero. Oltre a avere delle finalità narrative legate al mio lavoro è un posto fermo nel tempo. C’è una decadenza nostalgica di un ideale e un modello alternativo di società di contemporaneità che non si è pienamente realizzato, o che comunque ha avuto dei grossi ostacoli e mancanze. E questa sorta di alternativa non riuscita, di decadenza, di un ideale novecentesco nel ventunesimo secolo, secondo me viene restituito a livello fotografico e immaginifico molto dall’utilizzo del bianco e nero.
Come avete trovato la giusta gradazione di bianco e nero?
Quello è stato un lavorone, devo ringraziare sia il direttore della fotografia che il colorist, Lorenzo Casadio Vannucci e Alessio Zanardi, due figure enormi nella lavorazione del film. Il lavoro sul tipo di bianco e nero è partito ben prima dell’inizio delle riprese. Siamo arrivati a girare senza che io abbia mai visto un frame a colori, utilizzando già la gradazione di bianco e nero specifica del film. Volevo un bianco e nero novecentesco dove c’erano tante sfumature di grigio, nero e bianco. Una gradazione che desse una sorta di morbidezza che accompagnasse i personaggi.
A livello di riferimenti visivi?
Ce ne sono stati tanti. Ma abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare veramente per tanto al punto che si è creato qualcosa di completamente nuovo. Siamo partiti dai riferimenti quali Tabu di Miguel Gomes o Satantango di Béla Tarr fino ha un certo tipo di estetica rispetto alla color soprattutto per quanto riguarda C’mon C’mon di Mike Mills e Roma di Alfonso Cuarón. Un bianco e nero che lavorasse meno su bianco brillante e più su una certa pasta più poetica. L’idea era restituire anche la poesia dei luoghi. Su quello l’immagine secondo me ha aiutato molto anche il lavoro narrativo.

Un’immagine di Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio
Nel suo lavoro parla di crisi migratorie. Una realtà che non si riduce alla sola Cuba. In quest’ottica raccontare la decisione di un uomo o una donna di attraversare il mare o l’oceano, di lasciarsi tutto alle spalle senza vedere mai più le persone che ama, lo considera un atto politico?
Assolutamente sì. È un atto politico. Penso che il cinema sia un’arte che abbia una connotazione politica. Qualche giorno fa leggevo un’intervista a Wim Wenders in cui diceva che i film più politici sono addirittura quelli di intrattenimento perché danno l’illusione che niente cambi, che lo status quo vada bene. Raccontare certe storie con un determinato sguardo è fondamentale per comprendere la contemporaneità. Penso che fare un film legato al contesto cubano, a un certo tipo di immaginario, a un’idea di migrazione, senza però parlare soltanto di numeri, ma dell’umanità che c’è dietro – delle facce, dei volti, delle storie – sia qualcosa che permetta di capire di più anche quello che stiamo attraversando noi in Italia.
Cioè?
Siamo testimoni di crisi migratorie sulla rotta centrale del Mediterraneo, abbiamo da Ventimiglia alla Val di Susa moltissime persone che transitano sul nostro territorio con il loro pacchetto di sogni, drammi e speranze. Dobbiamo riprendere contatto con la condizione umana. Il film guarda in questa direzione. Spero che in qualche modo l’atto politico più grande sia essere umani, riuscire a empatizzare, a entrare nella realtà di queste persone e a equiparare la nostra storia alla loro. Magari può aiutare a comprendere anche quello che stiamo vivendo in maniera più nitida.
Racconta questa storia attraverso tre tempi, il passato con Milagros, il presente con Alex ed Edith e il futuro con Frank e Alain. Come li ha trovati? Che tipo di ricerca hai fatto?
La volontà era quella di fare un film non con uno sguardo prettamente occidentale sulla realtà cubana o colonialista di questo tipo. Quindi la stessa strutturazione della narrazione, delle vicende raccontate e della messa in scena, è nata molto dai personaggi che hanno preso parte al film, dalla loro sensibilità, dalla loro storia. Parlo di processo maieutico nel senso che si è tirato fuori molto dal loro passato, dalla loro personale sensibilità. La storia non nasce. Da me nasce l’idea del racconto, ma la storia viene da loro. In questo senso sono completamente autori del film.

Una scena di Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio
Un esempio?
Alex con la sensibilità rispetto alla terra, alla performance, con l’insegnamento ai bambini, il legame all’afro-cubanismo, il legame spirituale alla propria realtà, ha caratterizzato il suo personaggio. Stessa cosa per Edith. È partita per l’Italia il giorno stesso in cui abbiamo finito le riprese. Frank e Alain hanno vissuto esattamente quella situazione, nel senso che Alain ora vive negli Stati Uniti. Le lettere che legge Milagros sono ispirate a quelle che aveva ricevuto e ha vissuto sulla propria pelle la storia raccontata. Sono tutte storie che nascono dal passato reale e dalla reale contemporaneità dei personaggi. Tant’è che abbiamo mantenuto i loro nomi perché sarebbe stato come mettere un filtro di finzione falsificandoli. Sarebbe stata una menzogna forzata. Non ho voluto imporre niente. Avevo una sceneggiatura che serviva come scheletro, però i muscoli, la carne e la ciccia della storia l’hanno messa loro.
Un aspetto molto interessante del film è quello legato al suono, dai rumori della strada alla pioggia.
È uno degli elementi su cui abbiamo lavorato di più e per cui il sound designer, Tommaso Barbaro, ha speso veramente tanti mesi, assieme anche al fonico di presa diretta, Victor Jaramillo. Abbiamo stratificato tantissimo. Per tutto il film non si vede il mare, se non nella foto-lettera finale. Ma abbiamo lavorato sull’ondosità dei suoni, su una serie di stimoli che non vediamo, nonostante i campi siano molto aperti. Volevamo caratterizzare l’arena sonora del film per renderla più spontanea e più reale possibile. Tant’è che si è scelto poi di non doppiare il film perché il lavoro sul suono era stato così approfondito che era praticamente impossibile da fare senza danneggiarlo.
Una produzione Rosamont con Rai Cinema in coproduzione con Cacha Films, prodotto da Marica Stocchi e Gianluca Arcopinto. Con il sostegno di direzione generale Cinema e audiovisivo. Distribuzione Fandango.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma