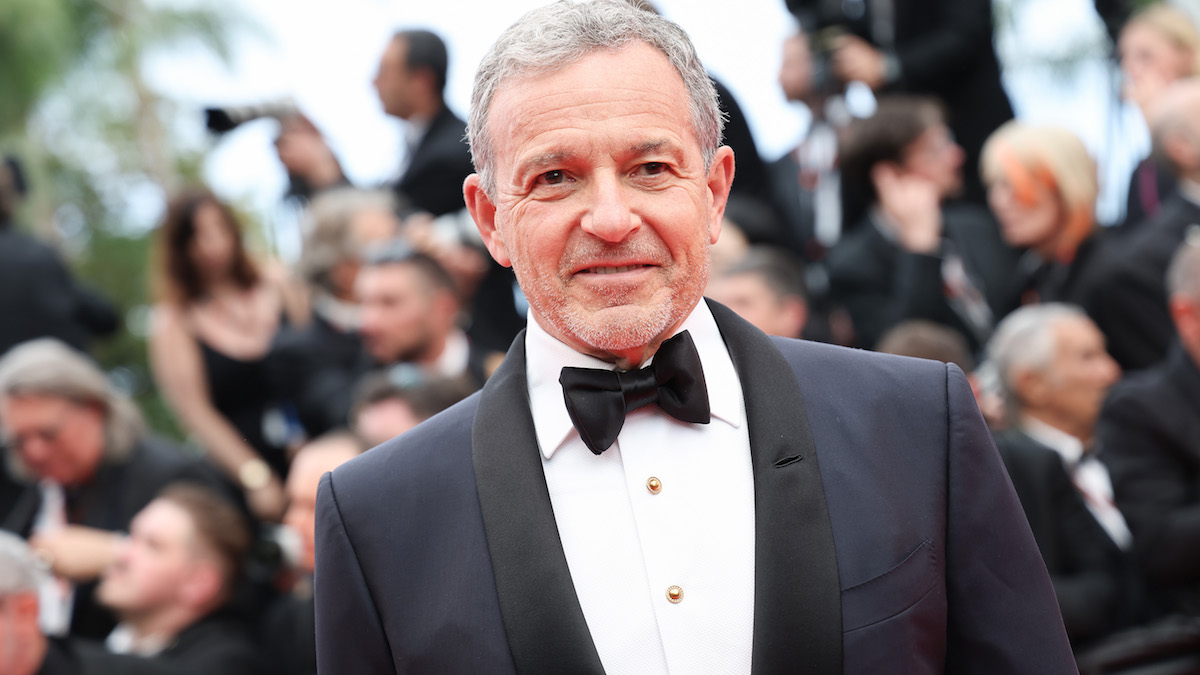All’inizio fu Sun Ra, visionario jazzista free che negli anni Cinquanta divenne il pioniere dell’afrofuturismo: immaginare una via attraverso cui i discendenti della diaspora africana potessero condurre le proprie lotte per i diritti civili e per l’auto-affermazione da un punto di vista alieno, al di sopra delle umane vicissitudini. Una corrente culturale afrocentrica di liberazione immaginifica e ottimista, basata sulle molteplici tradizioni della madre Africa (su tutte la cultura egizia, la sua estetica, il suo misticismo) ma legata al presente e al futuro della tecnologia, della scienza e della fantascienza, in cui gli “alieni” sono protagonisti del proprio futuro. Un pensiero che ha nutrito anche i fumetti, i romanzi, le arti grafiche, i videoclip, il cinema black da allora ai giorni nostri. Dopo la visione di Sun Ra, molti musicisti hanno abbracciato l’afrofuturismo: George Clinton e i suoi Parliament Funkadelic (Clinton indossava abiti africani multicolorati e si disegnava su una navicella spaziale chiamata “The Mothership”), più recentemente gli Outkast, Erykah Badu (amante della mistica egizia), il sassofonista Kamasi Washington, la musicista, attrice e scrittrice Janelle Monae con l’aggiunta della causa femminista. E ovviamente l’hip hop.

Sun Ra
La maggior parte dell’hip hop – quest’anno cinquantenne – è sempre stato guidato dal principio afrofuturista: quello di aiutare la propria gente ad immaginare un futuro possibile, acquisire consapevolezza, superare il razzismo e affermarsi.
I rapper hanno continuato a sentirsi “alieni” come segno di resistenza e di appartenenza, ma probabilmente neppure il più visionario tra gli afrofuturisti avrebbe potuto scommettere che le magnifiche sorti di alcuni eletti del suo “popolo” immaginate da arte, musica e romanzi, sarebbero andate ben oltre le più rosee aspettative.
La controcultura è diventata business
Oggi è indubbiamente black uno dei colori prevalenti del business a stelle e strisce, e gli affari si fanno proprio con quella che fu la controcultura più dirompente degli anni Ottanta e Novanta: l’hip hop. Magnati, tycoon, imprenditori, produttori: sono o erano rapper. La via del riscatto, la via delle catene spezzate, oggi corre lungo le rotte del capitale. Un mondo che incrocia musica, cinema, moda, serie tv. Una trasformazione che da controllati del sistema ha tramutato i rapper in controllori del sistema e del capitale.
Non c’è da scandalizzarsi, oggi la rivoluzione fa rima con fatturazione: guardiamo Pharrell Williams, gallina dalle uova d’oro del rap americano e uno dei musicisti più ricchi degli Stati Uniti. Per il terzo anno consecutivo l’ex leader dei NERD ha lanciato il suo Black Ambition Prize: un premio riservato ad imprenditori afroamericani e latinoamericani che vogliono partire con startup nei settori della tecnologia, della sanità, del design, e in generale, nei prodotti di consumo.

Kanye West nel 2016 a New York City – Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Yeezy Season 3
Presenza ubiqua del pop d’oro, Pharrell ha un patrimonio di 250 milioni di dollari, 10 Grammy all’attivo, gestisce un’etichetta discografica e un collettivo creativo multimediale chiamato “i am OTHER”, ha collaborato con marchi multinazionali, creato abiti, scarpe da ginnastica, gioielli, occhiali da sole, mobili, sculture, tessuti. Per fare un altro esempio, Drake possiede la sua etichetta discografica, il suo marchio di moda, un whisky chiamato Virginia Black, mentre Kanye West (che di Grammy ne ha collezionati 21) ha la sua etichetta discografica, una linea di abbigliamento (Yeezy), ha collaborato con firme come Nike e Louis Vuitton, ha diversificato lavorando nell’architettura, nella politica, nel design e in mille altri settori. Forbes ha stimato il suo patrimonio netto nel 2002 a 2 miliardi di dollari, crollato a 500 milioni dopo alcune sue dichiarazioni considerate antisemite (ma questa è un’altra storia).
Da MLK ai Public Enemy
Ne è trascorsa di acqua sotto i ponti dai tempi in cui la lotta per i diritti degli afroamericani passava attraverso il pugno chiuso e il volto accigliato delle (originarie) Black Panther di Malcolm X, o da quello accogliente di Martin Luther King. Allora gli artisti combattenti per l’emancipazione dei neri americani erano rappresentati da personaggi come Harry Belafonte o Sidney Poitier. Gente distinta, impegnata, capace di stare in bilico tra le battaglie civili e la gestione della propria celebrità in un mondo dello spettacolo ancora chiuso e reazionario. Con stile e modestia, perché negli anni Cinquanta e Sessanta delle prime marce per i diritti civili era ancora inconcepibile ibridare l’orgoglio nero della lotta sociale col business. Ma i semi erano già stati piantati e l’ambizione di un mondo migliore, in cui il nero “alieno” nella società wasp americana sarebbe diventato principe di un suo magnifico regno, erano scritti nei lavori degli afrofuturisti.
Dopo il blues e il gospel, fu lo spoken-word a farsi largo ed alzare la voce contribuendo a creare consapevolezza e senso identitario nel popolo afroamericano: i Last Poets e Gill Scott Heron tra i primi, con testi incendiari o con elegantissime misture di jazz, soul e poesia socialmente impegnata. Poi fu la volta della Motown, l’etichetta delle superstar afro che conquistavano il mercato bianco e infine, negli anni Ottanta, l’hip hop consapevole di antesignani come i Public Enemy, che alzarono i toni con canzoni che inneggiavano alla Fear of the Black Planet (alla “Paura del pianeta nero”), titolo del loro capolavoro del 1980, pietra miliare del rap. Se il cinema degli anni Ottanta ancora tardava a offrire una rappresentazione non stereotipata della black culture, ci pensò il primo hip hop a sdoganarla dal suo ghetto culturale, sociale ed economico.

Padri dell’hip-hop: i Public Enemy nel 1988
Dalla controcultura black dei tardi anni Settanta e Ottanta in poi la figura dell’artista portavoce dell’orgoglio nero ha preso man mano una piega diversa, passando dalla lotta per l’affermazione dei diritti e dell’identità dell’intera comunità, alla lotta per il maggior profitto individuale possibile.
Era il Bronx, ora sono i magnati
Una ventina d’anni dopo si è fatta strada una nuova generazione hip hop: non quella naif che nasceva cinquanta anni fa ai margini del Bronx, ma quella che sulla scorta delle conquiste dei “vecchi”, ha usato la black music come testa d’ariete per sfondare la porta del business milionario e proiettarsi dalle classifiche di Billbord agli schermi di Hollywood.
Non è un caso che la Def Jam, storica etichetta discografica che diede alle stampe proprio gli album dei Public Enemy, è stata di proprietà di un signore che si chiama Jay-Z, magnate del nuovo rap, marito della regina della musica pop a stelle e strisce Beyoncé e rappresentante della nuova generazione dei leader neri americani. I due, assieme vantano un patrimonio netto complessivo di quasi due miliardi di dollari, in pratica il prodotto interno lordo di un modesto paese.
Non esiste un momento esatto in cui l’hip hop ha perduto la sua innocenza ed è diventato una macchina da soldi. Peraltro l’esaltazione dell’orgoglio nero e la denuncia delle ingiustizie civili è sempre rimasta, anche se in certi periodi, sotto traccia. C’è sia nei testi di Jay-Z che in quelli di Beyoncé, Kendrick Lamar, Common, Kanye West e tutti gli altri, ma la lotta passa sempre più per l’affermazione di un modello di business vincente e gioca sullo stesso piano e con le stesse armi che furono degli oppressori, in un continuo corto circuito di significati e aspirazioni.

Come Gesù: Kendrick Lamar in scena
Non solo artisti dunque, ma uomini di affari a 360 gradi. Jay-Z, antesignano di questo nuovo modello di tycoon che aprì la sua prima azienda nel 1996 e ora vanta linee di abbigliamento, ristoranti, bar, produzioni discografiche e investimenti di ogni tipo, ne fa una questione di sistema: “sono stato costretto a essere un artista e un Ceo, un uomo di affari, fin dall’inizio, perché quando stavo cercando un contratto discografico era così difficile ottenerlo da solo che l’unico mezzo fu creare la mia azienda”.
Hip hop e orgoglio nero
In effetti negli ultimi vent’anni all’interno della comunità afroamericana che conta l’orgoglio nero è passato attraverso la dimostrazione di un conto in banca milionario. Solo il business ti offriva la rivincita e la reputazione. E’ stata l’affermazione di un’estetica (e di un’etica) completamente rovesciata: al posto degli elegantissimi completi giacca e pantaloni dei Temptations, abbiamo assistito a rapper che sfilavano in pantofole da migliaia di dollari tra fiumi d’oro: oro nelle collane, oro incastonato negli incisivi. Al posto del rap “conscious” dei Last Poets o di quello militante dei Public Enemy, la sfrontatezza di testi inneggianti a bitch, money, sparatorie e macchine di lusso.
L’iter è stato ben chiaro fin da subito: diventi molto famoso, molto ricco, sfondi su Billboard (la bibbia delle classifiche Usa), poi a Hollywood e infine ti lanci in altri business: vestiti, profumi, poi investi.
Hip hop alla Casa Bianca
Geneticamente diversi dai loro “padri” musicali, i nuovi re dell’hip hop hanno per anni mescolato rime conscious evocando i loro veri o presunti padri spirituali (Malcolm X, Fred Hampton, Corretta Scott, Martin Luther King) a ostentazioni di ricchezza, dando per scontato che la rivalsa sociale dovesse passare per la conquista materiale; già ai tempi in cui Jay Z e Kanye West firmavano assieme l’album Watch the Throne (2011) si beccavano le critiche di Chuck D, ex Public Enemy, che li invitava a dosare meglio le parole. Perché le parole sono importanti, soprattutto nel rap, e quando è troppo, è troppo. Un linguaggio che nell’emergere ha indugiato nei suoi stessi stereotipi fino a che, nel nuovo millennio, le cose sono cominciare a cambiare ed è tornato l’orgoglio immaginifico afrofuturista.

La coppia d’oro dell’hip-hop: Jay Z e Beyoncé
Nonostante la deriva epicurea, l’hip hop ha continuato ad essere fonte di discussione e confronto sulla questione dei diritti, nonché mezzo potentissimo per sdoganare la cultura e l’orgoglio black nel mondo mainstream fino a che è stato Obama a portarlo ufficialmente alla Casa Bianca: da quel momento in poi nessun presidente presente o futuro potrà ignorare l’enorme bacino di voti che il pubblico del rap è capace di convogliare.
Superman afro-ispanico
Poco dopo sarebbe giunto lo Spiderman afro-ispanico della Marvel, Miles Morales, antesignano della grande rivoluzione dei supereroi neri. Infine, qualche anno dopo, è esplosa la protesta di Black Lives Matter e coloro i quali avevano indugiato troppo nel mondo dorato del profitto e dello foggio a tutti i costi, hanno dovuto recuperare di gran fretta la verginità perduta; la questione politica e sociale è tornata in primissimo piano, mentre l’ostentazione, il cosiddetto “rap del lusso” per dirla alla Kanye West, è finito decisamente fuori moda.
E’ allora che si è fatta strada una nuova generazione, comunque socialmente vincente, ma più dedita alla questione “morale”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
In primis Kendrick Lamar, classe 1987, californiano di Compton, cittadina ad altissimo tasso delinquenziale, probabilmente il rapper più influente della sua epoca: le sue canzoni socialmente impegnate, la sua cifra stilistica anacronistica, la sua critica al materialismo del rap, la sua “redenzione” cristiana lo portano lontano anni luce da qualsiasi altro rapper coevo. Sua Alright, la canzone-bandiera del movimento Black Lives Matter, sua How Much a Dollar Coast (2015), la canzone più amata dall’allora presidente Barack Obama.
Non a caso Beyoncé lo ha voluto alla produzione di Freedom, inno indirizzato alle donne afroamericane: “I break chains all by myself, won’t let my freedom rot in hell” (spezzo le catene da sola, non lascerò che la mia libertà marcisca all’inferno). Queen Bey, nell’urgenza sociale del Black Lives Matter, ha saputo interpretare magnificamente il suo ruolo di donna nera orgogliosa e lo ha fatto fatturando più di chiunque altra e producendo, ciliegina sulla torta, con la Walt Disney (come side project della sua colonna sonora del nuovo Re Leone) il lungometraggio Black is King, una celebrazione delle culture della diaspora africana attraverso la storia eroica di un giovane principe nero (di nuova l’epica della regalità nera afrofuturista) alla ricerca di se stesso e delle proprie radici. Queen Bey è donna d’affari: con la sua azienda Parkwood Entertainment produce film (tra cui Cadillac Records e Obsessed), musica e abbigliamento.
Contro gli stereotipi
Sul podio dei virtuosi c’è anche Donal Glover (1983), la quintessenza dell’artista nero delle nuova epoca, capace di eccellere in più campi: cantante, attore, produttore televisivo. Proprio a Glover si deve l’idea di uno Spiderman afroamericano, lui che aveva tentato senza successo il provino per vestire i panni dell’uomo ragno nel film precedente. Creatore della serie tv Atlanta (in onda dal 2016 al 2022), nella sua incarnazione da musicista sotto il nome di Childish Gambino ha prodotto hit di enorme successo come This is America (2018), magistrale descrizione dello stereotipo dell’afroamericano così come è stato vilipeso nel cinema e nel quotidiano.
Glover, parlando di follia del razzismo e di violenza urbana ha conquistato con questo disco quattro Grammy ed è diventato la punta di diamante del nuovo modello di artista afroamericano orgoglioso e vincente. Un po’ come Ava DuVernay, imprenditrice, produttrice, regista di Selma, la strada per la libertà (2014) nonché la prima donna afroamericana ad incassare con un film Disney 100 milioni di dollari (e spenderne 130).
La svolta di Black Panther
Ma la chiave di volta a Hollywood è stato il blockbuster Marvel Black Panther (2018): se incassi un miliardo di dollari in 26 giorni di programmazione significa che sulla black culture si deve investire.

Un’immagine da Black Panther
In pieno stile afrofuturista, il film descrive un regno africano in cui una tecnologia iper avanzata porta a un mondo migliore per l’eletto popolo nero. Da Black Panther in poi l’orgoglio nero è diventato un affare di potenza inaudita sia a Hollywood che sulle piattaforme di streaming (dove da anni è un florilegio di serie afrocentriche, addirittura commissionate nei paesi della diaspora: Nigeria, Sud Africa). Ma gli investimenti nel cinema e nelle serie dei rapper milionari vanno ben oltre il desiderio di diffondere valori afrocentrici: Drake è tra i produttori esecutivi della serie della Hbo Euphoria, Meek Mill e il solito Jay Z lo sono della docu-serie sulla boxe 40 days.
Di Pharrell Williams e Kanye West abbiamo già detto.
Profumi, liquori e hip hop
E poi il grande vecchio Dr Dre (devoto all’afrofuturista George Clinton), l’uomo che ha lanciato giganti come Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent e ovviamente Sean Combs (ex Puff Daddy e P Diddy), magnate dei media (il suo reality show Making the Band è stato uno dei più grandi successi di MTV) patron dell’etichetta Bad Boy, uno dei dieci musicisti più ricchi del globo grazie agli affari nel mondo dell’abbigliamento, una linea di profumi, un liquore. Un po’ come Sean Carter, proprietario della celebre etichetta rap Roc-A-Fella Records, di una linea di abbigliamento, vari marchi di alcolici (champagne Armand de Brignac e cognac D’USSÉ), l’investimento nel servizio di streaming musicale Tidal, la sua società sportiva, le app per smartphone, TV e film.
“We are only in it for the money”, diceva Frank Zappa, e a controllare le dichiarazioni dei redditi delle black star pare proprio così. Ma – in una linea dell’immaginario che è la stessa di un James Brown con la mantella di ermellino come gli imperatori, così come della classica iconografia dei bluesmen splendenti monarchi – questa è anche storia dello schiavo che si fece re, è anche la mitologia chi non si accontenta di spezzare le catene, vuole anche sedersi sul trono.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma