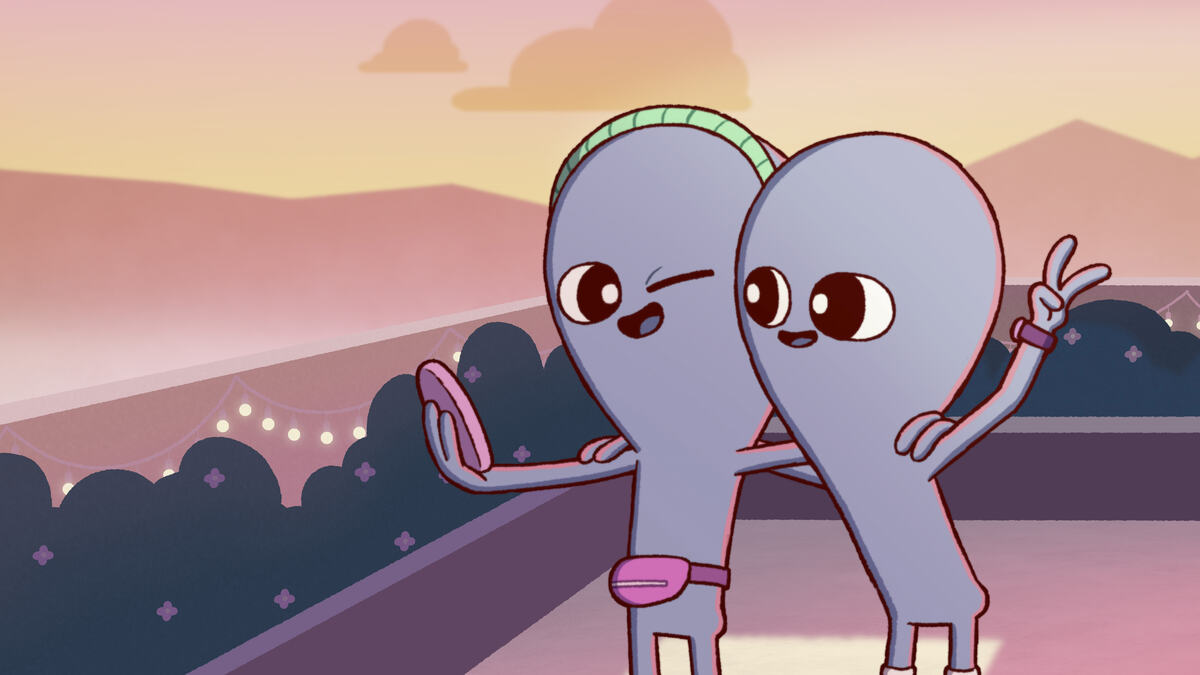Sia chiaro, non nomineremo Freud in questa recensione: non ce n’è bisogno. È evidente che nel suo terzo film, Beau ha paura, il newyorkese Ari Aster abbia scavato nei meandri della psiche umana tirandone fuori un conflitto tra madre e figlio limpido e cristallino. Ma ad essere molto meno immediato, e perciò assai più interessante, è il percorso che l’autore ha deciso di intraprendere. Mostrando di essere perfettamente consapevole di chi è, chi è diventato e che ruolo ricopre nel panorama cinematografico: quello di una delle firme più geniali dell’horror.
Uno status raggiunto grazie al sostegno di tanti e a una buona dose di autoconsapevolezza, che gli hanno permesso di avere massima fiducia nelle proprie idee e potenzialità. Un desiderio di eccedere nella regia e nella scrittura che lo ha portato a un punto estremo del proprio lavoro, quasi di non ritorno. Una scelta più al servizio dell’Ari Aster cineasta, che dell’effettiva necessità di raccontare il complesso edipico indagato nella pellicola.
Ari Aster chiama a rapporto Joaquin Phoenix (l’indolente Beau), che accetta senza battere ciglio di essere il protagonista di un autentico viaggio nei corridoi del sé – chissà se per affrontare il ruolo avrà avuto bisogno di quei funghetti che, nelle interviste promozionali, ha invitato a non mangiare prima del film. E lo conduce in un itinerario assurdo e immersivo, totalmente scollegato da qualsiasi appiglio reale, pur raccontando cosa possa essere – dalla nascita all’estremo giudizio finale – la vita di qualsiasi persona. Non solo del suo personaggio, ma di chiunque, di ogni genere, razza, etnia. E lo dice fin da subito: vivere non è altro che un horror. Magari ironico, sicuramente sarcastico, ma pur sempre un horror.

Una scena di Beau ha paura
L’esistenza come dolore in Beau ha paura
La sequenza d’apertura ne è un chiaro paradigma. Con lo schermo nero e delle urla che arrivano da lontano, la pellicola suggerisce che qualcuno stia venendo ucciso, torturato, quando in verità sono le grida di una donna al momento del parto. La nascita di Beau è da subito preludio di ansie, di preoccupazioni, incidenti e, in definitiva, sofferenze. Lo squarcio che si apre sullo schermo, quella vagina che si fa passaggio per mettere alla luce un figlio, ci conduce nella visione tragicomica e esagerata che Ari Aster ha costruito della vita. E che accompagna tutta la crescita di Beau e la durata (più di tre ore) del film.
Beau vivrà in un mondo in cui dovrà letteralmente scappare ogni giorno per non venir picchiato, inseguito, pugnalato. Dove la violenza è la norma e la pazzia non è l’eccezione, ma il tappeto sociale che abitiamo. In cui il senso di colpa nei confronti di quell’unico (presunto) porto sicuro, la mamma, è il motivo fondante di tutti i suoi disagi. Un’angoscia che non concede nemmeno di abbandonarsi alle gioie del sesso. Perché si sa, se tua madre ti becca sono guai, e come ci insegnano tutti gli horror, potrebbe addirittura scapparci il morto.
Con Beau ha paura, Aster sublima il suo personale gusto orrorifico, trasformandolo nella metafora dell’esperienza umana sulla terra. Per questa ragione la sequenza più sfiancante, infinita e sconvolgente, è quella della storia di un uomo, dalla sua nascita al suo epilogo finale, messa in scena nel film in un inciso teatrale. Un racconto che è la vita di Beau? Forse. E forse, quello che vuole dirci Ari Aster – con un atto di meravigliosa presunzione – è che quell’esistenza sia anche la nostra.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma