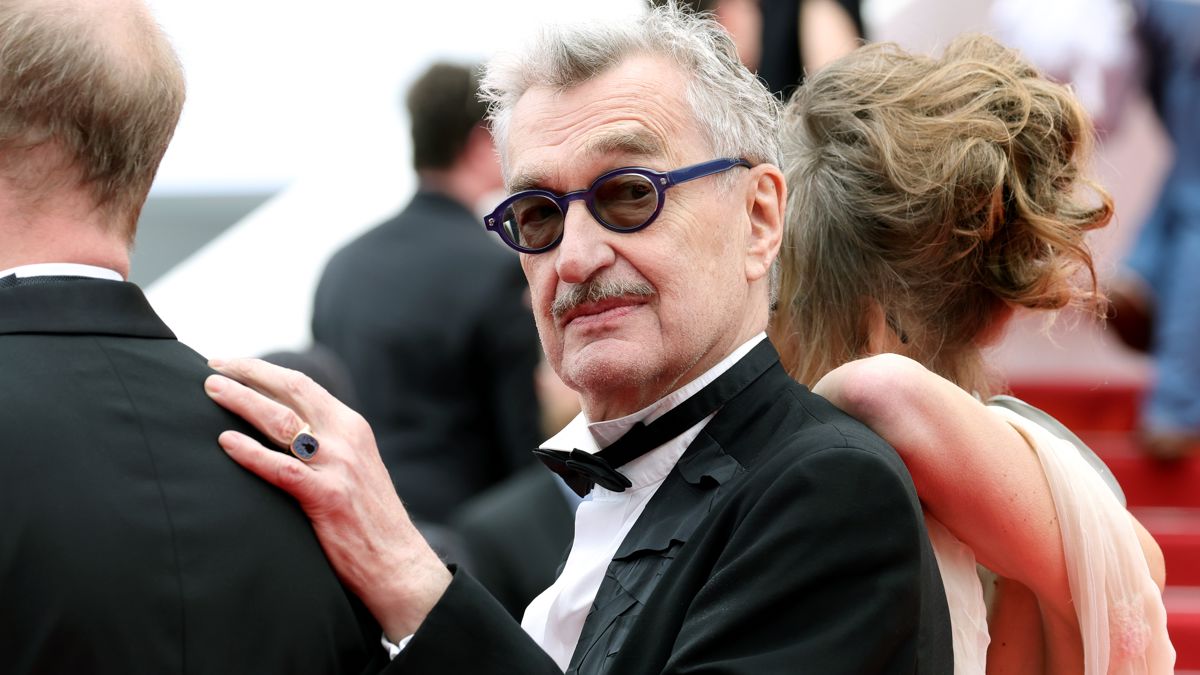Un western con Viggo Mortensen. Un’adolescente che si trasforma in una gru. Gli indiani d’America, gli indigeni del Brasile e Chiara Mastroianni con l’auto in panne. E tutto in un solo film. Presentato ieri a Cannes fuori concorso, Eureka dell’argentino Lisandro Alonso (Jauja, Liverpool) è stato, per citare l’ultimo film di Nanni Moretti, il momento “what the fuck” del festival. Tre film in uno, formati diversi (in bianco e nero la parte western), attori non professionisti insieme a divi del cinema americano ed europeo. Si parte con la storia del pistolero Viggo Mortensen per scoprire – dopo mezz’ora – che la sua avventura non è che un film mandato in onda sulla tv accesa in casa di una poliziotta della riserva indiana di Pine Ridge, nel Dakota, la cui figlia – sull’orlo della depressione – finirà per trasformarsi in una gru, dopo aver bevuto una pozione del nonno sciamano: volerà via atterrando fra gli aborigeni di Oaxaca, riuniti in una foresta per raccontarsi i propri sogni. Per fare un po’d’ordine, e decifrare l’opera più psichedelica del regista argentino, THR Roma ha incontrato Lisandro Alonso, a Cannes orfano delle sue star.
Cominciamo dal principio: perché tre storie?
Sono tre storie in connessione. Mentre guardi il film ti fai delle domande: perché ha scelto un western? Cosa accade nella vita quotidiana della riserva? Come mai, a un certo punto, uno di loro scompare e vola via? Ognuna delle tre parti è in relazione. Ma ho l’impressione di essere l’unico a pensarlo.
Perché un western?
Avevo voglia di girare nello stesso posto in cui Sergio Leone aveva fatto quel film con Claudia Cardinale e Charles Bronson (C’era una volta il West, ndr), in Almeria. È un posto in rovina, abbandonato: mi sembrava perfetto. È magico. Perché il western? Non so, ci sono tanti temi: la frontiera, la violenza, il potere dell’uomo con la pistola. Credo che anche Pedro Almodovar abbia girato nello stesso luogo.
Come ha lavorato nella riserva indiana?
Ci sono stato prima delle riprese, su suggerimento di Viggo Mortensen. E là mi è venuta l’idea di raccontare la quotidianità di una poliziotta al lavoro nella riserva. Quello che si vede nel film è solo una versione edulcorata della situazione. C’è di tutto: violenza domestica, abuso di alcool e droghe, risse. Un incubo. La polizia conta su appena 20 poliziotti per più di 50.000 persone. Ho passato molte notti con loro, a bordo della volante: non fanno altro che andare avanti e indietro nella riserva, per dodici ore al giorno, caricandosi in macchina un’umanità varia. Non sono un grande fan delle forze dell’ordine, ma devo ammettere che da quelle parti c’è davvero bisogno di arginare il caos. Lo dico da outsider, da esterno: stanno chiedendo aiuto. Ma non lo vogliono dai bianchi.
Come hanno preso il fatto che volesse girare un film?
Mi hanno chiesto cosa volessi fare, e se avessi intenzione di girare la stessa merda che hanno fatto gli altri. Parlare di depressione e suicidio, cose così.
E lei?
Gli ho detto di no. Gli ho promesso che avremmo fatto il film insieme. Ho detto alla poliziotta che l’avrei seguita ovunque, ma che non avrei potuto fare a meno di raccontare la verità di ciò che avrei visto.
Tecnicamente: aveva un copione o avete improvvisato?
Un certo grado di flessibilità era indispensabile. Capitava spesso che le persone che avevamo convocato sul set non si presentassero. Ma che puoi farci? Se uno ti chiama e ti dice che sua sorella ha avuto un incidente in macchina, non è che puoi forzarlo a presentarsi. Ci siamo arrangiati.
La poliziotta del film è una vera poliziotta?
Sì, una delle sette poliziotte della riserva. La ragazza che interpreta sua figlia invece viene dalla riserva Rosebud, vicino a dove abbiamo girato. Una ragazza sveglissima, ha recitato per la prima volta con noi ed è eccezionale. L’abbiamo trovata facendo street casting.
Il personaggio della poliziotta sparisce dal film senza motivo. Perché?
C’è una storia. La poliziotta era incinta quando abbiamo girato, e suo figlio è nato prematuro di tre settimane. Stavamo girando le scene ambientate nel casinò, quando si è scatenata una fortissima tempesta di neve, che ci ha letteralmente isolati là dentro. E lei ha cominciato a sentirsi male. Il primo ospedale era a 200 chilometri, non potevamo uscire: l’hanno portata via con un elicottero. Dopo quattro giorni in terapia intensiva, il bambino si è salvato. Ma non abbiamo più potuto girare con lei. Era la poliziotta, secondo il copione, a trasformarsi in gru.
Ecco, la gru. Parliamone.
Non è che ne abbia un’idea chiarissima. Voglio dire: odio la parola, ma mi sembrava una cosa poetica. Una metafora.
Di cosa?
Non saprei. Pensa che la ragazza si sia trasformata in gru o si sia suicidata?
Nel film sembrerebbe trasformarsi in gru.
È una lettura molto ottimistica. Alla fine, in un modo o nell’altro, lei sceglie di abbandonare un luogo di grande sofferenza per cercare un’altra strada altrove. Più o meno.
Ma è una leggenda indiana?
Non proprio. Qualcosa del genere c’è nella loro tradizione, che contempla l’esistenza di un mondo parallelo e mistico. I nativi si connettono con dio ballando per giornate intere, credono negli spiriti, hanno un culto ancestrale cui sono devoti, così come tanti credono in Gesù. Volevo metterlo nel film. Funziona.
E poi è volato in Brasile. Perché?
In Messico, in realtà. Il Brasile non ci finanziava, il Messico sì. Quindi abbiamo fatto il Brasile in Messico.
E quale sarebbe la connessione con le precedenti storie?
Sono popoli che vivono in stretto contatto con la natura, senza riscaldamento, elettricità, addirittura senza documenti personali. Finora ho fatto storie molto more minimali, qui ho provato a fare qualcosa di più grande. Volevo spendere tempo ed energia con persone che vivono vicine alla natura. Non girerei mai un film in città: non me ne frega niente delle città.
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma