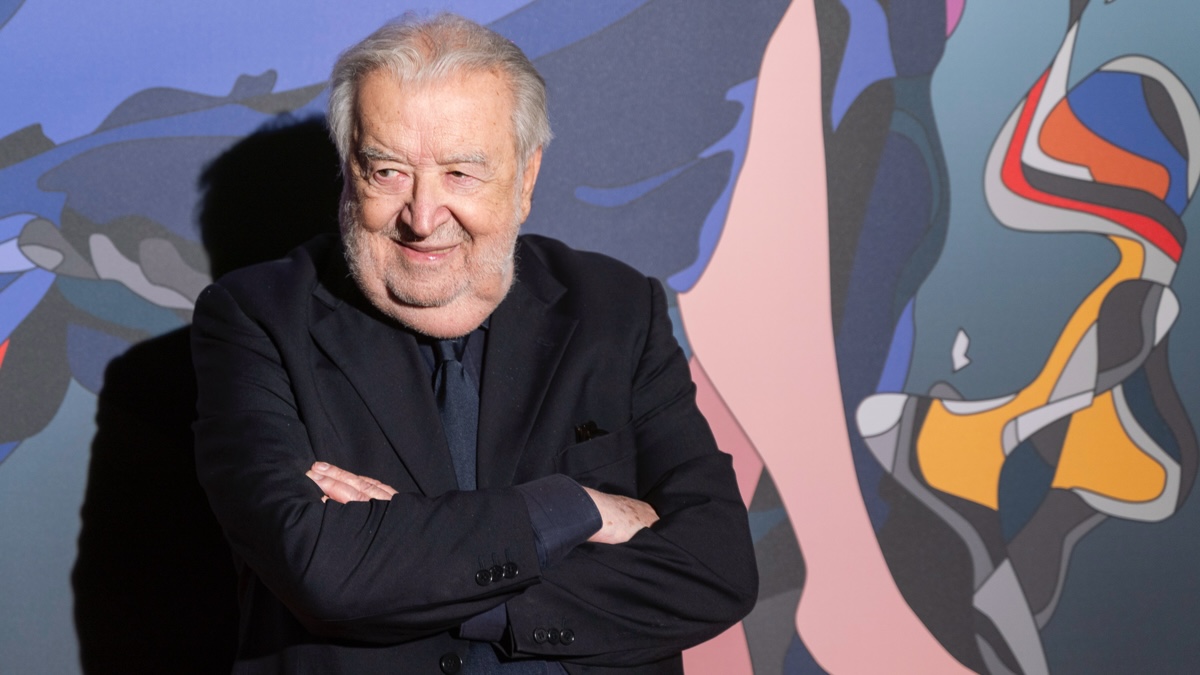
“L’abbraccio”. Nel congedarsi dall’intervista con THR Roma Pupi Avati si lascia andare a un moto di tenerezza. Lo stesso che è spesso cifra del suo cinema. Oltre cinquant’anni di carriera in cui ha spaziato e giocato con i generi. Maestro indiscusso nel raccontare l’Italia del dopoguerra, la stessa che farà da sfondo al suo prossimo film, L’orto americano – “Un film gotico, nero. Un film che a Roma definirebbero “de paura” – che in questi giorni lo vede impegnato sul set.
Ma, nonostante il lavoro, il regista ha fatto in modo di essere presente prima al Torino Film Festival che gli ha dedicato la serata di apertura e che l’ha visto protagonista di una masterclass e ora al festival del cinema di Poretta – giunto alla sua 22ª edizione – dove, insieme al fratello Antonio, celebra il 40° anniversario di Una gita scolastica, film del 1983 con protagonisti Carlo Delle Piane e Tiziana Pini. Per l’occasione Poretta lo celebra con l’incontro A spasso per l’Appennino: 40 anni di Una gita scolastica. Un tuffo nel territorio e nella scenografia naturale che è stata Porretta insieme ad altri luoghi iconici emiliani.

Pupi Avati. Foto di Elisa Scarduelli
È ospite del festival del cinema di Poretta con Un gita scolastica. Cosa pensa che il pubblico possa trovare oggi in quel film?
Penso fosse già fuori dal tempo nel momento in cui lo realizzammo. Raccontava una storia del 1913 ma eravamo nel 1983, c’erano 70 anni di differenza. Ed era una storia che riguardava il passaggio dall’adolescenza alla consapevolezza di diventare giovani adulti. Quel momento in cui quel microcosmo e la classe nella quale hai riconosciuto e ritrovato praticamente tutto il tuo universo si va disgregando. Quel tipo di emozione, di commozione, l’addio alla giovinezza e a quell’età della vita così speciale, credo che continui a commuovere adesso come allora.
La colonna sonora era di Riz Ortolani.
Con Riz era una consuetudine perché aveva già lavorato con me in altri film. Non fu difficile trovare immediatamente una grande sintonia. Fu fantastico nell’individuare un tema conduttore di grande tenerezza che riproduceva quelle condizioni di affettività così estreme. Penso sia uno dei miei film invecchiato meno.
Ospite a Poretta, nei giorni scorsi a Torino. Secondo lei qual è il ruolo di un festival cinematografico oggi?
Torino ha questa peculiarità straordinaria. Pur appartenendo probabilmente alla categoria dei festival minori, perché non è Cannes, Venezia o Berlino, mi sono reso conto che il pubblico non è lì per il red carpet, ma per i film. Purtroppo, invece, accade che nei grandi festival sia quasi più importante il red carpet dei film. Un po’ come succede con la musica a Sanremo. Se lei mi chiede gli ultimi tre film che hanno vinto a Venezia o a Cannes io non li so dire. Un tempo la vittoria a un festival cambiava la vita di un film. Così come il lavoro dei critici. Ce n’erano alcuni di cui era sufficiente una loro recensione elogiativa per cambiarne le sorti. Oggi non è più così.
E secondo lei perché? Cos’è successo alla critica cinematografica?
Ha perso credibilità. Innanzitutto per il fatto che si sia privilegiato una specie di star system del tutto asservito a una sorta di colonialismo culturale che viene d’altrove. Poi la critica ha perso il suo ascendente con questo fatto di dare i voti, di sintetizzare la recensione di un film attraverso delle stelline, dei numeretti o delle faccine sorridenti. È così terribilmente offensivo. Tant’è vero che Tullio Kezich, uno dei critici italiani più significativi, si è sempre rifiutato di farlo.
Sta lavorando al suo nuovo film, L’orto americano. Ma è vero che sarà in bianco e nero?
Sì, sarà in bianco e nero. Ma non per il film di Paola Cortellesi (ride, ndr).
Però è interessante notare come in questo periodo tantissimi registi stiano tornando al bianco e nero. Si è domandato come mai?
Perché ci dà un’idea maggiore di cinema. È misterioso. Di recente ho accompagnato il mio ultimo film, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, nelle aree estive e ho trovato un pubblico innanzitutto numericamente interessantissimo. E poi con la voglia di vedere film in condizioni che se erano quelle di una volta, dalla ghiaia per terra alle seggioline. Tutto quello che non si trova nella sala cinematografica e, soprattutto, non si trova più nel multisala. Penso che il cinema tornerà ad essere sempre più cinema, più si distinguerà da quella che è la proposta televisiva.
Di cosa parlerà il film?
È un film gotico ambientato nel 1946, nel primo dopoguerra, quando un ragazzo di Bologna incontra una ragazza americana e se ne invaghisce follemente. La cercherà per tutto il film, per poi scoprire una trama terribile, molto cruenta, tenebrosa. È un film nero. Un film che a Roma definirebbero “de paura” (ride, ndr).

Il regista Pupi Avati
Nel suo cinema lei riesce a evocare odori e sapori. È come se fosse possibile essere in scena insieme ai suoi protagonisti. Come ci riesce?
Credo dipenda molto dalla conoscenza che ho di quegli anni, di quel tempo, di quella stagione. Ho studiato per molti anni il Medioevo. Credo di averlo in qualche modo sottratto da quelli che sono i suoi luoghi comuni per farlo diventare qualcosa di assolutamente vero, verosimile nella sua essenza. Era la cosa alla quale tenevo molto.
Anche la componente visiva, pittorica, ha un ruolo importante nei suoi film.
Sono figlio di un collezionista di quadri, mentre mia nonno era un antiquario. Vengo da una cultura visiva.
Ha citato Paola Cortellesi protagonista di un grande successo al botteghino con C’è ancora domani. Il suo è uno dei film italiani più visti negli ultimi vent’anni. Qual è il segreto?
Una serie di coincidenze che è difficilissimo prevedere. Una fra tutte sicuramente il tema che riguarda le condizioni giovanili. E secondo me non è secondaria l’idea che questo film dà di quello che era il cinema. Una cosa che ho scritto personalmente a Paola e Riccardo (Milani, ndr). C’è una grande nostalgia di quel tipo di immagine, di fotografia e contesto lì. Anche di quel tipo di Italia negativa. Un cinema nei suoi valori più archetipi, più definitivi, più distanti da quella che è invece la proposta seriale delle varie piattaforme. Che è qualcosa di completamente diverso.
Crede sia in atto un cambiamento?
Io spero di sì e che torni in grand voga il monoschermo, la sala di quartiere dove il pubblico è fidelizzato a quel tipo di esercente che proietta solo film di qualità. E che le multisale vivano un destino completamente diverso. Che proiettino il blockbuster ma siano destinate a un pubblico che non è quello dei cinefili.
Qualche giorno fa Paolo Del Brocco, nel presentare il listino della 01, ha dichiarato che il prossimo anno si produrranno meno film in Italia. Un bene o un male?
È un bene. Perché spesso producono dei film che non escono, o che se escono restano in sala due giorni e hanno un destino cinematografico totalmente scadente. Già rinunciatario in partenza.

Pupi Avati. Foto di Sara Celia
Crede sia il destino dei registi più giovani quello traghettare il cinema italiano verso il cambiamento?
Non è una questione anagrafica. La creatività non è il predominio di un’età. Ci sono delle persone che sono creative per tutta la loro vita. Basti pensare a Picasso, Verdi o Van Gogh.
Nei mesi scorsi si è molto discusso di ciò che è avvenuto al Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua opinione?
Tanto rumore per nulla perché chi ha sostituito chi era è sicuramente all’altezza. È evidente che non si doveva fare un’occupazione tanto per occupare. Ma credo che da Sergio Castellitto in giù, il consiglio d’amministrazione e i nuovi dirigenti abbiano alle spalle, più che un appartenenza politica, una competenza.
Farà parte della consulta nazionale della segreteria di Forza Italia. Come mai ha accettato questo ruolo?
Mi hanno chiesto se potevo mettere a disposizione del paese quello che so del mio ambiente, del mio mondo culturale. Dovrebbero farlo tutti.
Alla serata inaugurale del Torino Film Festival di cui è stato protagonista ha parlato anche della sua giovinezza a Bologna. Cos’è che le manca di più di quel periodo?
Quell’età della vita in cui tutto era possibile. Adesso è diventato tutto molto difficile e alla mia età il futuro si è molto abbreviato. Anche il coraggio di immaginarsi delle cose che allora erano possibili adesso non c’è più. È diventato tutto molto, molto, molto più asfittico.
Se dovesse consigliare a un giovane che non conosce il suo cinema uno dei suoi film, quale sarebbe?
Penso che uno dei film che mi rappresenti di più sia proprio Una gita scolastica che racconta quell’età della vita in cui si passa dalla giovinezza all’età adulta. Un momento al quale nessuno può sottrarsi e che commuove tutti ancora adesso.
Ha dichiarato più volte che Dante è il suo mito, al punto da dedicargli un film. Dovrebbe essere una figura ancor più celebrata dalla nostra cultura?
Assolutamente. Molo ma molto di più. Se lei pensa che ho impiegato trent’anni a convincere qualcuno a produrre quel film…
THR Newsletter
Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma









